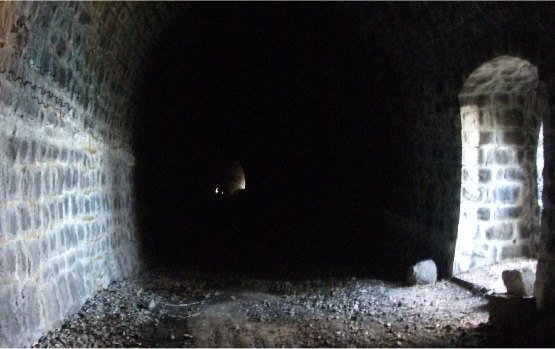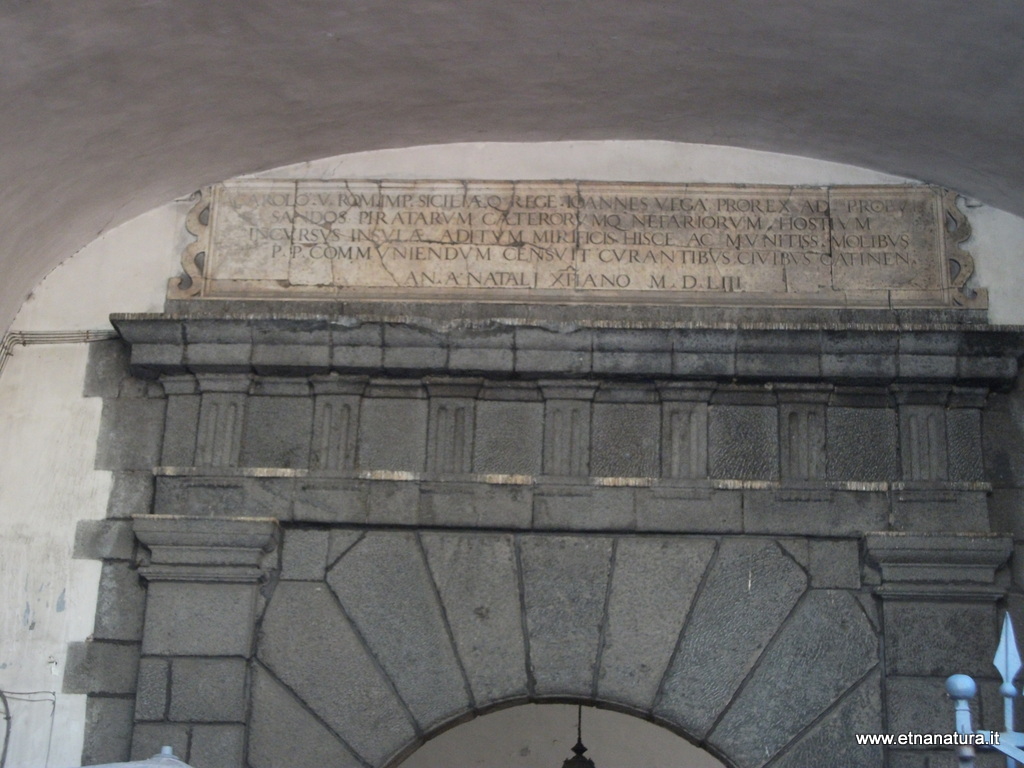La Chiesiola della B.ma Vergine S.Maria di Loreto fuori la citta’, situata un miglio distante, nel principio del Bosco in mezzo di alcune chiuse nominata di “Callozzo”, fu fondata dal proprietario di dette chiuse Giovanni Maccarrone, alias Callozzo, il quale per codicillo agli atti di Notar Stefano Mangano 2 settembre 1575, dispose che le dette chiuse e la Chiesa, seguita la morte del Rev. Sac. D. Abramo Grasso (la sepoltura è visibile nella Cattedrale) fossero amministrate dall’Opera della Luminaria del SS. Sacramento della Matrice chiesa di Jaci. Morto il Sac. Grasso il 04 marzo 1626, le dette chiuse la piccola Chiesa passarono all’amministrazione dei Rettori della Luminaria, i quali migliorarono la cultura delle terre e aumentarono il culto della Chiesa, ottenendo da Mons. Innocenzo massimo Vescovo di Catania di celebrare la festa della B.ma Vergine, la Chiesa in seguito acquistò singolare celebrità e i Rettori formarono un libro in cui tenevano registrati le grazie concesse ai devoti della B.ma Vergine –
La Chiesiola della B.ma Vergine S.Maria di Loreto fuori la citta’, situata un miglio distante, nel principio del Bosco in mezzo di alcune chiuse nominata di “Callozzo”, fu fondata dal proprietario di dette chiuse Giovanni Maccarrone, alias Callozzo, il quale per codicillo agli atti di Notar Stefano Mangano 2 settembre 1575, dispose che le dette chiuse e la Chiesa, seguita la morte del Rev. Sac. D. Abramo Grasso (la sepoltura è visibile nella Cattedrale) fossero amministrate dall’Opera della Luminaria del SS. Sacramento della Matrice chiesa di Jaci. Morto il Sac. Grasso il 04 marzo 1626, le dette chiuse la piccola Chiesa passarono all’amministrazione dei Rettori della Luminaria, i quali migliorarono la cultura delle terre e aumentarono il culto della Chiesa, ottenendo da Mons. Innocenzo massimo Vescovo di Catania di celebrare la festa della B.ma Vergine, la Chiesa in seguito acquistò singolare celebrità e i Rettori formarono un libro in cui tenevano registrati le grazie concesse ai devoti della B.ma Vergine –
Archivi categoria: Medioevo & Rinascimento
Monastero sant’Antonio
 A sud del centro storico di Mascalucia, all’interno del cimitero centrale, si trova un tempio di stile gotico antico la cui architettura risale ai primi tempi dei Cristiani in Sicilia. La sua architettura originale pare risalga ad epoca anteriore alla venuta dei Saraceni (anno 827). Sicuramente doveva far parte della giurisdizione dei P.P. Benedettini a quell’epoca diffusi in tutta l’isola. Attraverso la donazione di Tertullio, padre di San Placido, erano entrati in possesso dì immensi beni, tra cui molte terre nei dintorni di Catania In seguito appartenne all’Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani, ed essendo unica chiesa, tra le contrade etnee, fu parrocchia dei paesi limitrofi quali San Giovanni Galermo, Gravina, Tremestieri etc..
A sud del centro storico di Mascalucia, all’interno del cimitero centrale, si trova un tempio di stile gotico antico la cui architettura risale ai primi tempi dei Cristiani in Sicilia. La sua architettura originale pare risalga ad epoca anteriore alla venuta dei Saraceni (anno 827). Sicuramente doveva far parte della giurisdizione dei P.P. Benedettini a quell’epoca diffusi in tutta l’isola. Attraverso la donazione di Tertullio, padre di San Placido, erano entrati in possesso dì immensi beni, tra cui molte terre nei dintorni di Catania In seguito appartenne all’Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani, ed essendo unica chiesa, tra le contrade etnee, fu parrocchia dei paesi limitrofi quali San Giovanni Galermo, Gravina, Tremestieri etc..
Basilica di monte Po
 Si tratta un’antica basilica bizantina. La chiesa dovrebbe essere datata fra la seconda metà del VI secolo e la prima metà del VII. Si sviluppa secondo quattro quadrati di cui tre comprendono il corpo delle navate e il quarto lo sviluppo dell’abside. Purtroppo poco o altro si è riusciti a comprendere e interpretare e i pochi resti rimasti, inaccessibili perché interni ad un cortile privato, meriterebbero sicuramente un approfondimento per ricostruire la storia delle prime comunità cattoliche catanesi.
Si tratta un’antica basilica bizantina. La chiesa dovrebbe essere datata fra la seconda metà del VI secolo e la prima metà del VII. Si sviluppa secondo quattro quadrati di cui tre comprendono il corpo delle navate e il quarto lo sviluppo dell’abside. Purtroppo poco o altro si è riusciti a comprendere e interpretare e i pochi resti rimasti, inaccessibili perché interni ad un cortile privato, meriterebbero sicuramente un approfondimento per ricostruire la storia delle prime comunità cattoliche catanesi.
Torre dell’Acquafredda
 Definire i lineamenti storici di un edificio di piccole dimensioni all’interno del complesso avvicendarsi degli avvenimenti, che nei secoli hanno caratterizzato e coinvolto l’intero territorio di Randazzo e la Valle dell’Alcantara, risulta alquanto complesso. Si sconosce con esattezza la data di edificazione della torre, presumibilmente innalzata intorno al XVI, secondo quanto è possibile evincere dalla contemporanea feudalizzazione di buona parte dei territori demaniali dell’abitato di Randazzo. La limitrofa contrada S. Anastasia figura già alla fine del XV sec. come possesso dei monasteri di S. Filippo il Grande o di Fragalà e del S. Giorgio di Gesso [D. Ventura 1991, pag. 240]; circa nello stesso periodo la contrada Acquafredda, oggi sita all’interno del territorio di Castiglione, rientra all’interno dei beni feudali della famiglia Lanza, la quale a partire dal XVI sec. detiene la baronia del vicino abitato di Mojo [D. Ventura 1991, pag. 250]. Conferma la progressiva infeudalizzazione di questa importante parte della valle dell’Alcantara un passo dell’opera di Filoteo degli Omodei, che nel 1557 ricorda: “ … E’ la Roccella un castelletto sopra fortissimo monte, del barone di casa Spatafora. E ricevendo questo fiume, lascia nel destro lato un’antica rocca chiamata la torre dell’Acqua fredda, di casa Lanza, dove si vedono alcune rovine…”[A.F. Omodei 1557, pag. 51]. L’ “antica rocca chiamata la torre dell’Acqua Fredda” sembrerebbe corrispondere all’attuale torre, sebbene nella descrizione il Filoteo ecceda negli aggettivi, definendola sia antica, sia rocca, lasciando dunque intendere che si possa trattare di un edificio più grande e di origini sicuramente precedenti al periodo in cui lo storico scriveva. Dei ruderi che lautore sosteneva di osservare limitrofi all’edificio fortificato, oggi si è persa traccia, fatta eccezione per la vicina basilichetta altomedievale. Filoteo degli Omodei ricorda altri edifici turriti presenti nel territorio circostante : “… Quindi dalla man sinistra (sei miglia tra Randazzo e Castiglione), tra l’Appennino e il Mongibello, vi è un territorio detto della Fede, feudo nominato il Moggio, dove oggi è una torre fondata a tempi nostri da D. Pietro Lanza, baron del Moggio…”[A.F. Omodei 1557, pag. 52-53]. La torre di Pietro Lanza era l’edificio residenziale principale della nobile famiglia, edificato al centro dell’abitato di Mojo e del quale oggi non rimane praticamente nulla, sebbene fosse ancora esistente agli inizi del XX sec. Il paese di Mojo, comunque, ha origini ben più antiche: Edrisi, nel 1150, testimonia l’esistenza di uno castello o borgo fortificato (hisn), “somigliante ad un piccolo casale” e definendolo al-Mudd (Mojo)[M. Amari 1880/81, vol. I pag. 116]. Agli inizi del XIV sec. all’interno del testo arabo Masalik al-Absar [M. Amari 1880/81, vol. I pag. 263] tra le rocche di Sicilia si cita Mojo, che stranamente alla fine dello stesso secolo non esiste più né come località, né come feudo [G.L. Barberi 1888, pag. 127]. Solo nel 1602 risorge come nuovo abitato, avente licentia populandi. Presumibilmente altre torri dovevano trovarsi sparse lungo il territorio di Mojo, tutte edificate in tempi vicini, già a partire dalla fine del XVI sec. Lo scopo di questi edifici doveva essere duplice: certamente di primaria importanza era il controllo continuo dei beni feudali; in secondo luogo tali edifici dovevano essere anche una dimostrazione di forza del potere baronale nei confronti degli abitanti del feudo e, più o meno direttamente, dei possedimenti demaniali dell’abitato di Randazzo. In effetti l’avanzare del latifondo e in generale l’appropriazione di territori un tempo semplicemente beni ecclesiastici o beni demaniali della città di Randazzo inizia nel XV sec. e prosegue inesorabile lungo i sec. XVI e XVII. Fra i feudi baronali, il più esteso risulta quello della “Foresta della Porta vecchia” [D. Ventura 1991, pag. 242], il quale per lungo tempo conserva una straordinaria compattezza territoriale e ai giorni nostri risulterebbe compreso tra i comuni di Bronte, Longi e Tortorici. Il feudo, in principio possesso di Matteo Palizzi e in seguito di Guglielmo Raimondo Moncada, si presenta composto da sette “marcati” e rimane indiviso fino al 1449, anno in cui le famiglie proprietarie dei Paternò e dei Santangelo procedono ad una spartizione. Quattro marcati, le contrade Triairi, Botti, Foresta Vecchia, Mangalaviti, tra Randazzo, Bronte e Longi, finiscono nelle mani dei Santangelo; i rimanenti tre, Cartolari, Barrilla, Acquasanta, insistenti su porzioni di territorio a nord di Randazzo, tra Longi e Tortorici, vanno ai Paternò, i quali finalmente li cederanno nel 1507 a Blasco Lanza, barone di Mojo. Dunque già agli inizi del XVI sec. avviene nei confronti di Randazzo un ideale accerchiamento dei suoi territori demaniali da parte della famiglia Lanza, la quale di anno in anno pare vantare sempre più estesi territori. In questo quadro storico, ove la terra risulta l’unico vero bene per il quale lottare accanitamente, la città regia conserva solo alcuni possedimenti demaniali, che ad oriente confinano con Castiglione, i Lanza e i terreni di proprietà ecclesiastica: principalmente si tratta del territorio di Montelaguardia[D. Ventura 1991, pag. 240 e 245], oggi solo piccolo abitato, ma un tempo probabilmente vantava una superficie più estesa, confinante con Castiglione e col feudo ecclesiastico di S. Anastasia, e di un noccioleto tra la terra di Castiglione e contrada Ianazzo, quest’ultima limitrofa ad Acquafredda e S. Anastasia. La torre di Acquafredda sorge su di un affioramento di roccia lavica lungo la sponda meridionale del fiume Alcantara, in un territorio compreso tra Castiglione e Randazzo. L’edificio è realizzato attraverso una muratura sommaria, composta da pietrame vario, generalmente di origine lavica, non sbozzato e legato insieme da una malta tenace. Solo i cantonali si presentano leggermente rinforzati da alcuni conci di pietra lavica sommariamente squadrati. La struttura possiede una pianta quadrata leggermente irregolare e si divide in due piani: al pian terreno si osserva solo l’ingresso, rivolto a settentrione, largo poco più di m. 0,50, e caratterizzato da strombatura interna. Si accede al primo piano per mezzo di una scala interna lignea, un tempo presumibilmente mobile, ai giorni nostri sostituita da una permanente. Questo secondo piano si distingue per la presenza di quattro ampie finestre quadrangolari, ciascuna delle quali rivolta verso uno dei punti cardinali: le finestre di meridione e occidente risultano murate. Inoltre si può osservare la presenza, poste ai lati dei finestroni, di alcune saettiere, che possiedono una strombatura non molto accentuata. Tali saettiere sono in realtà cieche, poiché il loro necessario sbocco esterno è stato del tutto ostruito, causa i pesanti rifacimenti esterni che nei secoli hanno afflitto la torre. La copertura della struttura è a doppio spiovente, composto da tegole disposte alla maniera “laconica”. Inoltre il tetto è arricchito da una merlatura a coda di rondine decorativa posta similmente ad acroteri: quattro merli sono angolari, due centrali. Inoltre essi si impiantano sulle tegole di copertura, elemento che farebbe pensare ad un’aggiunta successiva di questi elementi architettonici. L’intero corpo di fabbrica pur possedendo unità edilizia, è, comunque, il frutto di alcuni rifacimenti e rimaneggiamenti attuati in epoche successive. La torre sembra, infatti, aver subito adattamenti nella funzionalità abitativa di volta in volta simili, ma non identici. Per prima cosa l’ingresso, composto da bei conci di pietra lavica, si presenta sorretto da un architrave basaltico e monolitico, poggiante a sua volta a sinistra su di un concio di pietra lavica avente verso l’interno una sagomatura ad arco di cerchio; a destra, in realtà doveva esservi la medesima soluzione architettonica, adesso perduta e semplicemente sostituita in malo modo da alcuni laterizi sovrapposti. Poco al di sopra dell’architrave si osserva un’ampia parte mancante della muratura, presumiblmente causata dall’asportazione di un oggetto, quale un tempo poteva essere il blasone della famiglia Lanza. Varcato l’angusto ingresso, si trova un vano quadrangolare privo di finestre o aperture. Risalta solo la soluzione per la divisione dei due piani, operata per mezzo di travi e assi di legno che compongono i pavimento del piano superiore. Si tratta di una soluzione edilizia certamente recente, ma che potrebbe rispecchiare il sistema originale di divisione dei piani. Quale utilità potesse un tempo avere un vano del tutto chiuso, ove l’unico varco per la luce era la porta d’ingresso? Presumibilmente il pian terreno della torre dell’Acquafredda serviva per stipare derrate alimentari, quali cereali, ortaggi, prodotti della natura in genere, anche uva, visto che ad esempio sia il feudo S. Anastasia, quanto quello limitrofo dell’Acquafredda vennero, tra XV e XVI sec. convertiti alla produzione vitivinicola. Il piano superiore doveva svolgere rudimentali funzioni residenziali e di avvistamento. Le grandi finestre, arricchite da una cornice composta da conci ben squadrati di pietra lavica, vennero probabilmente praticate in seguito, quando le necessità abitative non furono più quelle per la difesa del territorio. Presumibilmente nel medesimo periodo in cui vennero ricavate le finestre, vennero ostruite anche le saettiere, forse non più utili. Le pareti interne di entrambi i piani risultano coperte in maniera uniforme da un intonachino grigiastro, risultato di rifacimento recente, che ha trasformato la torre prima in una sorta di magazzino temporaneo di attrezzi agricoli, in seguito, fino ai giorni nostri, in un rifugio temporaneo per i pastori della zona. L’intera superficie esterna dell’edificio presentava un tempo un rivestimento di colore anch’esso grigiastro, il cui progressivo ed inesorabile disfacimento lascia la nuda muratura della torre all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici. In particolar modo il prospetto settentrionale presenta, non lontano dal cantonale di nord-est, una frattura, risultato o di un progressivo cedimento strutturale, o di un terremoto, evento non infrequenti nella zona. Anche la stessa solidità dell’edificio si basa più che nella tecnica edilizia e nello spessore della muratura, non oltre i 0,70/0,80 m., soprattutto nelle fondamenta praticate su di uno sperone di roccia lavica più che mai antico e solido. A tal proposito sorge anche il sospetto che un tempo vi potesse essere un tunnel che principiando alla base della rocca, potesse condurre direttamente all’interno del pian terreno della torre. Questa ipotesi non è verificabile, poiché il pavimento del piano terreno adesso è semplicemente il risultato di uno spesso strato di calce. Si è già accennato a due particolari, che questa sezione si promette di approfondire: l’orografia della zona e la presenza di altre torri simili a quella di contrada Acquafredda. Questa zona della valle dell’Alcantara (media valle) si caratterizza per alcune particolarità, che la distinguono rispetto alle sue porzioni limitrofe al mare (bassa valle) o ai Nebrodi (alta valle). I territori che si distendono a meridione del fiume sono il riultato di centinaia d’anni di lavori per cavare dalla dura e nera roccia vulcanica un terreno fertile atto a colture cerealicole e vitivinicole, oltre a frutteti, uliveti e pochi agrumeti. Si tratta di un territorio mediamente irregolare, ove ogni affioramento di roccia lavica rappresenta un ipotetico punto di osservazione. La torre di Acquafredda sfrutta tale peculiarità, che giustifica la sua limitata altezza, non oltre gli otto metri. Il territorio che si stende lungo la sponda settentrionale del fiume Alcantara, possiede caratteristiche decisamente diverse. Si tratta, infatti, di un terreno prevalentemente argilloso, dove il vigneto spesso cede il passo al frutteto e all’uliveto. Questi luoghi sono immediatamente a ridosso dei Peloritani meridionali, caratterizzati da rilievi di circa 1100/1200 m. s.l.m., adatti maggiormente alla pastorizia, e da zone boschive un tempo di gran lunga più estese. L’Alcantara era ed è il vero spartiacque di due ambienti tangibilmente diversi, poiché un tempo le colate laviche, provenienti dai vulcanetti effimeri prodotti dall’attività magmatica dell’Etna, arrestavano la loro corsa contro il violento fluire delle acque del fiume, raramente valicandolo. Ma la memoria di un grande corso d’acqua in grado di arrestare un altrettanto fiume di fuoco oggi è praticamente scomparsa, giacchè l’alveo dell’Alcantara risulta particolarmente ristretto, causa pesanti attività agricole. Esse infatti hanno progressivamente rosicchiato le sponde per ottenere terreno coltivabile, la cui necessità d’acqua ha causato l’ulteriore prosciugamento del fiume in favore di pesanti attività irrigue. In tale maniera la maestosa Valle versa alla stregua di un gigante ferito, bisognoso di profonde cure, che ne risanino le piaghe ormai infette. Qualora questo monito possa sembrare un’esagerazione, giova osservare che il fiume, un tempo colmo d’acqua in ogni stagione, ha ormai assunto un carattere torrentizio. Tutto questo disfacimento ha origini recenti, meno di cinquant’anni. La ricchezza naturalistica della Valle va di pari passo con quella archeologica ed artistica. Aquafredda non è solo la contrada della torre, ma anche un sito archeologico che nei decenni passati ha restituito numerosi reperti di epoca classica, adesso esposti presso il museo Vagliasindi di Randazzo. Anche le limitrofe contrade S. Anastasia e Imbischi sono ricche di storia e ancora ai giorni nostri restituiscono i ruderi di edifici sacri risalenti ad epoca greco-bizantina. La torre dell’Acquafredda non è isolata. La citata descrizione dell’Omodei lascia intendere l’esistenza di strutture turrite in altri luoghi della baronia Lanza. In effetti non molto distante dall’edificio oggetto di studio, ne sorge un altro, esattamente a est-nord-est. La costruzione risulta poco visibile perché inglobata in strutture più recenti. Questa torre presenta caratteristiche del tutto simili a quelle analizzate per l’Acquafredda, sebbene si presenti decisamente più alta, contando un piano in più. Per il resto, pianta, copertura e merlatura coincidono. Purtroppo per osservare un’altra struttura simile bisogna viaggiare molto attraverso la Valle, in direzione orientale, fino all’attuale abitato di Giardini Naxos. All’interno dell’area archeologica che contiene i resti dell’antica colonia greca di Naxos sorge un’altra torre, detta della Vignazza: essa presenta uguale pianta, uguale copertura, simile altezza e divisione dei piani (tre) sebbene sia assente la merlatura. La torre della Vignazza inoltre conserva integro l’ingresso, largo 0,50 m. circa e sorretto dal caratteristico architrave monolitico in pietra lavica. Purtroppo quest’ultima struttura, dopo svariati decenni di abbandono, è stata oggetto di pesanti restauri, che hanno del tutto nascosto la muratura, coperta sotto uno spesso intonaco grigiastro. E’ evidente che tali torri fossero il risultato di un’idea edilizia comune ed evidentemente di esigenze diffuse tanto nell’entroterra etneo, quanto lungo la costa. Dovevano svolgere una doppia funzione: di vedetta e di luogo ove presumibilmente stipare derrate alimentari. In effetti queste strutture non posseggono affatto caratteritiche simli alle contemporanee torri di Deputazione, la cui edificazione fu il risultato di un piano ben studiato, rivolto alla difesa delle coste siciliane. Al fine di porre in atto un’opera tanto dispendiosa, vennero dalla Toscana due architetti, Camillo Camilliani [C. Camilliani 1877] e Tiburzio Spannocchi [T. Spannocchi 1993]. Il loro compito, di difficile attuazione, fu quello di una lunga ricognizione dei tre litorali dell’Isola, per scoprire luoghi adatti per edificare grandi torri di avvistamento. Esse avevano caratteristiche comuni: base scarpata, all’interno della quale vi stava solitamente una cisterna; primo piano a pianta quadrangolare e segnato da marcapiano; infine terrazza ove solitamente sostava un piccolo cannone. Le torri di Deputazione, infatti, funzionavano come veri e propri fortini, collegati fra loro, ma virtualmente indipendenti: avevano l’importante compito di difendere, anche a colpi di cannone, le coste dai frequenti sbarchi di pirati turchi Dunque caratteristiche diverse rispetto alle torri oggetto di studio. La differenza si spiega in base allo scopo per il quale vennero edificate. La torre dell’Acquafredda non doveva cannoneggiare nessuno, eventualmente avvertire i vicini abitanti delle campagne di possibili pericoli imminenti: incendi, briganti, eventuali pirati, tanto ardimentosi da spingersi cosi in profondità verso l’entroterra. E trattandosi di torri probabilmente private, desta interesse l’identità del progetto: ovunque si trovino edifici del genere, essi presentano sempre caratteristiche comuni. Ciò lascia incuriositi, poiché nel caso di torri private edificate lungo le coste dell’isola, questa identità di progetto non si riscontra. Sia il Camilliani, quanto lo Spannocchi descrivono torri baronali sempre diverse, una a pianta quadrangolare, un’altra a pianta circolare, tutte con dimensioni dissimili. Evidentemente le torri granaio edificate lungo l’Alcantara, nella loro identità strutturale rispondono a particolari esigenze, non ultime quelle prettamente legate alle attività rurali. In ultima analisi si consideri il caso dell’abitato ionico-etneo di Giarre. L’insediamento dovrebbe sorgere intorno alla metà del XVI sec. come centro di raccolta delle derrate alimentari prodotte dalle attività agricole esistenti nella zona. Poco prima dei moti rivoluzionari per l’unità d’Italia, al centro del paese sorgeva una torre. Ai giorni nostri di tale struttura nulla rimane, perché devastata dalla furia popolare del 1848. Fortunatamente dell’edificio turrito esiste una piccola rappresentazione pittorica, operata dalla mano di un pittore acese del settecento: Tuccari. Certamente la pittura stilizza l’antico centro storico di Giarre, ma la torre viene rappresentata similmente a quella dell’Acquafredda o della Vignazza presso Giardini Naxos: si ipotizzano infatti i tre piani, si legge chiaramente la pianta quadrata, la copertura a doppio spiovente e la posizione delle finestre simile a quanto si può osservare nelle strutture ancora esistenti. Pur non avendo una testimonianza architettonica diretta, si può affermare che l’antica torre di Giarre era una torre granaio, del tipo ampiamente esposto in queste pagine. La sua presenza non stupisce, poiché la vocazione dell’abitato fin dalla sua nascita era proprio quella agricola. Si sconosce il numero di tali strutture esistenti o esistite nell’area etnea. Studiarne la presenza e la diffusione potrebbe realmente aiutare la comprensione delle attività economiche e in generale della società siciliana del XVI e XVII sec. Infine, riguardo all’edificazione di tali strutture, non si sottovaluti la possibile influenza della famiglia Lanza, dei cui effettivi possedimenti terrieri, certamente vasti, non possediamo una completa conoscenza.
Definire i lineamenti storici di un edificio di piccole dimensioni all’interno del complesso avvicendarsi degli avvenimenti, che nei secoli hanno caratterizzato e coinvolto l’intero territorio di Randazzo e la Valle dell’Alcantara, risulta alquanto complesso. Si sconosce con esattezza la data di edificazione della torre, presumibilmente innalzata intorno al XVI, secondo quanto è possibile evincere dalla contemporanea feudalizzazione di buona parte dei territori demaniali dell’abitato di Randazzo. La limitrofa contrada S. Anastasia figura già alla fine del XV sec. come possesso dei monasteri di S. Filippo il Grande o di Fragalà e del S. Giorgio di Gesso [D. Ventura 1991, pag. 240]; circa nello stesso periodo la contrada Acquafredda, oggi sita all’interno del territorio di Castiglione, rientra all’interno dei beni feudali della famiglia Lanza, la quale a partire dal XVI sec. detiene la baronia del vicino abitato di Mojo [D. Ventura 1991, pag. 250]. Conferma la progressiva infeudalizzazione di questa importante parte della valle dell’Alcantara un passo dell’opera di Filoteo degli Omodei, che nel 1557 ricorda: “ … E’ la Roccella un castelletto sopra fortissimo monte, del barone di casa Spatafora. E ricevendo questo fiume, lascia nel destro lato un’antica rocca chiamata la torre dell’Acqua fredda, di casa Lanza, dove si vedono alcune rovine…”[A.F. Omodei 1557, pag. 51]. L’ “antica rocca chiamata la torre dell’Acqua Fredda” sembrerebbe corrispondere all’attuale torre, sebbene nella descrizione il Filoteo ecceda negli aggettivi, definendola sia antica, sia rocca, lasciando dunque intendere che si possa trattare di un edificio più grande e di origini sicuramente precedenti al periodo in cui lo storico scriveva. Dei ruderi che lautore sosteneva di osservare limitrofi all’edificio fortificato, oggi si è persa traccia, fatta eccezione per la vicina basilichetta altomedievale. Filoteo degli Omodei ricorda altri edifici turriti presenti nel territorio circostante : “… Quindi dalla man sinistra (sei miglia tra Randazzo e Castiglione), tra l’Appennino e il Mongibello, vi è un territorio detto della Fede, feudo nominato il Moggio, dove oggi è una torre fondata a tempi nostri da D. Pietro Lanza, baron del Moggio…”[A.F. Omodei 1557, pag. 52-53]. La torre di Pietro Lanza era l’edificio residenziale principale della nobile famiglia, edificato al centro dell’abitato di Mojo e del quale oggi non rimane praticamente nulla, sebbene fosse ancora esistente agli inizi del XX sec. Il paese di Mojo, comunque, ha origini ben più antiche: Edrisi, nel 1150, testimonia l’esistenza di uno castello o borgo fortificato (hisn), “somigliante ad un piccolo casale” e definendolo al-Mudd (Mojo)[M. Amari 1880/81, vol. I pag. 116]. Agli inizi del XIV sec. all’interno del testo arabo Masalik al-Absar [M. Amari 1880/81, vol. I pag. 263] tra le rocche di Sicilia si cita Mojo, che stranamente alla fine dello stesso secolo non esiste più né come località, né come feudo [G.L. Barberi 1888, pag. 127]. Solo nel 1602 risorge come nuovo abitato, avente licentia populandi. Presumibilmente altre torri dovevano trovarsi sparse lungo il territorio di Mojo, tutte edificate in tempi vicini, già a partire dalla fine del XVI sec. Lo scopo di questi edifici doveva essere duplice: certamente di primaria importanza era il controllo continuo dei beni feudali; in secondo luogo tali edifici dovevano essere anche una dimostrazione di forza del potere baronale nei confronti degli abitanti del feudo e, più o meno direttamente, dei possedimenti demaniali dell’abitato di Randazzo. In effetti l’avanzare del latifondo e in generale l’appropriazione di territori un tempo semplicemente beni ecclesiastici o beni demaniali della città di Randazzo inizia nel XV sec. e prosegue inesorabile lungo i sec. XVI e XVII. Fra i feudi baronali, il più esteso risulta quello della “Foresta della Porta vecchia” [D. Ventura 1991, pag. 242], il quale per lungo tempo conserva una straordinaria compattezza territoriale e ai giorni nostri risulterebbe compreso tra i comuni di Bronte, Longi e Tortorici. Il feudo, in principio possesso di Matteo Palizzi e in seguito di Guglielmo Raimondo Moncada, si presenta composto da sette “marcati” e rimane indiviso fino al 1449, anno in cui le famiglie proprietarie dei Paternò e dei Santangelo procedono ad una spartizione. Quattro marcati, le contrade Triairi, Botti, Foresta Vecchia, Mangalaviti, tra Randazzo, Bronte e Longi, finiscono nelle mani dei Santangelo; i rimanenti tre, Cartolari, Barrilla, Acquasanta, insistenti su porzioni di territorio a nord di Randazzo, tra Longi e Tortorici, vanno ai Paternò, i quali finalmente li cederanno nel 1507 a Blasco Lanza, barone di Mojo. Dunque già agli inizi del XVI sec. avviene nei confronti di Randazzo un ideale accerchiamento dei suoi territori demaniali da parte della famiglia Lanza, la quale di anno in anno pare vantare sempre più estesi territori. In questo quadro storico, ove la terra risulta l’unico vero bene per il quale lottare accanitamente, la città regia conserva solo alcuni possedimenti demaniali, che ad oriente confinano con Castiglione, i Lanza e i terreni di proprietà ecclesiastica: principalmente si tratta del territorio di Montelaguardia[D. Ventura 1991, pag. 240 e 245], oggi solo piccolo abitato, ma un tempo probabilmente vantava una superficie più estesa, confinante con Castiglione e col feudo ecclesiastico di S. Anastasia, e di un noccioleto tra la terra di Castiglione e contrada Ianazzo, quest’ultima limitrofa ad Acquafredda e S. Anastasia. La torre di Acquafredda sorge su di un affioramento di roccia lavica lungo la sponda meridionale del fiume Alcantara, in un territorio compreso tra Castiglione e Randazzo. L’edificio è realizzato attraverso una muratura sommaria, composta da pietrame vario, generalmente di origine lavica, non sbozzato e legato insieme da una malta tenace. Solo i cantonali si presentano leggermente rinforzati da alcuni conci di pietra lavica sommariamente squadrati. La struttura possiede una pianta quadrata leggermente irregolare e si divide in due piani: al pian terreno si osserva solo l’ingresso, rivolto a settentrione, largo poco più di m. 0,50, e caratterizzato da strombatura interna. Si accede al primo piano per mezzo di una scala interna lignea, un tempo presumibilmente mobile, ai giorni nostri sostituita da una permanente. Questo secondo piano si distingue per la presenza di quattro ampie finestre quadrangolari, ciascuna delle quali rivolta verso uno dei punti cardinali: le finestre di meridione e occidente risultano murate. Inoltre si può osservare la presenza, poste ai lati dei finestroni, di alcune saettiere, che possiedono una strombatura non molto accentuata. Tali saettiere sono in realtà cieche, poiché il loro necessario sbocco esterno è stato del tutto ostruito, causa i pesanti rifacimenti esterni che nei secoli hanno afflitto la torre. La copertura della struttura è a doppio spiovente, composto da tegole disposte alla maniera “laconica”. Inoltre il tetto è arricchito da una merlatura a coda di rondine decorativa posta similmente ad acroteri: quattro merli sono angolari, due centrali. Inoltre essi si impiantano sulle tegole di copertura, elemento che farebbe pensare ad un’aggiunta successiva di questi elementi architettonici. L’intero corpo di fabbrica pur possedendo unità edilizia, è, comunque, il frutto di alcuni rifacimenti e rimaneggiamenti attuati in epoche successive. La torre sembra, infatti, aver subito adattamenti nella funzionalità abitativa di volta in volta simili, ma non identici. Per prima cosa l’ingresso, composto da bei conci di pietra lavica, si presenta sorretto da un architrave basaltico e monolitico, poggiante a sua volta a sinistra su di un concio di pietra lavica avente verso l’interno una sagomatura ad arco di cerchio; a destra, in realtà doveva esservi la medesima soluzione architettonica, adesso perduta e semplicemente sostituita in malo modo da alcuni laterizi sovrapposti. Poco al di sopra dell’architrave si osserva un’ampia parte mancante della muratura, presumiblmente causata dall’asportazione di un oggetto, quale un tempo poteva essere il blasone della famiglia Lanza. Varcato l’angusto ingresso, si trova un vano quadrangolare privo di finestre o aperture. Risalta solo la soluzione per la divisione dei due piani, operata per mezzo di travi e assi di legno che compongono i pavimento del piano superiore. Si tratta di una soluzione edilizia certamente recente, ma che potrebbe rispecchiare il sistema originale di divisione dei piani. Quale utilità potesse un tempo avere un vano del tutto chiuso, ove l’unico varco per la luce era la porta d’ingresso? Presumibilmente il pian terreno della torre dell’Acquafredda serviva per stipare derrate alimentari, quali cereali, ortaggi, prodotti della natura in genere, anche uva, visto che ad esempio sia il feudo S. Anastasia, quanto quello limitrofo dell’Acquafredda vennero, tra XV e XVI sec. convertiti alla produzione vitivinicola. Il piano superiore doveva svolgere rudimentali funzioni residenziali e di avvistamento. Le grandi finestre, arricchite da una cornice composta da conci ben squadrati di pietra lavica, vennero probabilmente praticate in seguito, quando le necessità abitative non furono più quelle per la difesa del territorio. Presumibilmente nel medesimo periodo in cui vennero ricavate le finestre, vennero ostruite anche le saettiere, forse non più utili. Le pareti interne di entrambi i piani risultano coperte in maniera uniforme da un intonachino grigiastro, risultato di rifacimento recente, che ha trasformato la torre prima in una sorta di magazzino temporaneo di attrezzi agricoli, in seguito, fino ai giorni nostri, in un rifugio temporaneo per i pastori della zona. L’intera superficie esterna dell’edificio presentava un tempo un rivestimento di colore anch’esso grigiastro, il cui progressivo ed inesorabile disfacimento lascia la nuda muratura della torre all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici. In particolar modo il prospetto settentrionale presenta, non lontano dal cantonale di nord-est, una frattura, risultato o di un progressivo cedimento strutturale, o di un terremoto, evento non infrequenti nella zona. Anche la stessa solidità dell’edificio si basa più che nella tecnica edilizia e nello spessore della muratura, non oltre i 0,70/0,80 m., soprattutto nelle fondamenta praticate su di uno sperone di roccia lavica più che mai antico e solido. A tal proposito sorge anche il sospetto che un tempo vi potesse essere un tunnel che principiando alla base della rocca, potesse condurre direttamente all’interno del pian terreno della torre. Questa ipotesi non è verificabile, poiché il pavimento del piano terreno adesso è semplicemente il risultato di uno spesso strato di calce. Si è già accennato a due particolari, che questa sezione si promette di approfondire: l’orografia della zona e la presenza di altre torri simili a quella di contrada Acquafredda. Questa zona della valle dell’Alcantara (media valle) si caratterizza per alcune particolarità, che la distinguono rispetto alle sue porzioni limitrofe al mare (bassa valle) o ai Nebrodi (alta valle). I territori che si distendono a meridione del fiume sono il riultato di centinaia d’anni di lavori per cavare dalla dura e nera roccia vulcanica un terreno fertile atto a colture cerealicole e vitivinicole, oltre a frutteti, uliveti e pochi agrumeti. Si tratta di un territorio mediamente irregolare, ove ogni affioramento di roccia lavica rappresenta un ipotetico punto di osservazione. La torre di Acquafredda sfrutta tale peculiarità, che giustifica la sua limitata altezza, non oltre gli otto metri. Il territorio che si stende lungo la sponda settentrionale del fiume Alcantara, possiede caratteristiche decisamente diverse. Si tratta, infatti, di un terreno prevalentemente argilloso, dove il vigneto spesso cede il passo al frutteto e all’uliveto. Questi luoghi sono immediatamente a ridosso dei Peloritani meridionali, caratterizzati da rilievi di circa 1100/1200 m. s.l.m., adatti maggiormente alla pastorizia, e da zone boschive un tempo di gran lunga più estese. L’Alcantara era ed è il vero spartiacque di due ambienti tangibilmente diversi, poiché un tempo le colate laviche, provenienti dai vulcanetti effimeri prodotti dall’attività magmatica dell’Etna, arrestavano la loro corsa contro il violento fluire delle acque del fiume, raramente valicandolo. Ma la memoria di un grande corso d’acqua in grado di arrestare un altrettanto fiume di fuoco oggi è praticamente scomparsa, giacchè l’alveo dell’Alcantara risulta particolarmente ristretto, causa pesanti attività agricole. Esse infatti hanno progressivamente rosicchiato le sponde per ottenere terreno coltivabile, la cui necessità d’acqua ha causato l’ulteriore prosciugamento del fiume in favore di pesanti attività irrigue. In tale maniera la maestosa Valle versa alla stregua di un gigante ferito, bisognoso di profonde cure, che ne risanino le piaghe ormai infette. Qualora questo monito possa sembrare un’esagerazione, giova osservare che il fiume, un tempo colmo d’acqua in ogni stagione, ha ormai assunto un carattere torrentizio. Tutto questo disfacimento ha origini recenti, meno di cinquant’anni. La ricchezza naturalistica della Valle va di pari passo con quella archeologica ed artistica. Aquafredda non è solo la contrada della torre, ma anche un sito archeologico che nei decenni passati ha restituito numerosi reperti di epoca classica, adesso esposti presso il museo Vagliasindi di Randazzo. Anche le limitrofe contrade S. Anastasia e Imbischi sono ricche di storia e ancora ai giorni nostri restituiscono i ruderi di edifici sacri risalenti ad epoca greco-bizantina. La torre dell’Acquafredda non è isolata. La citata descrizione dell’Omodei lascia intendere l’esistenza di strutture turrite in altri luoghi della baronia Lanza. In effetti non molto distante dall’edificio oggetto di studio, ne sorge un altro, esattamente a est-nord-est. La costruzione risulta poco visibile perché inglobata in strutture più recenti. Questa torre presenta caratteristiche del tutto simili a quelle analizzate per l’Acquafredda, sebbene si presenti decisamente più alta, contando un piano in più. Per il resto, pianta, copertura e merlatura coincidono. Purtroppo per osservare un’altra struttura simile bisogna viaggiare molto attraverso la Valle, in direzione orientale, fino all’attuale abitato di Giardini Naxos. All’interno dell’area archeologica che contiene i resti dell’antica colonia greca di Naxos sorge un’altra torre, detta della Vignazza: essa presenta uguale pianta, uguale copertura, simile altezza e divisione dei piani (tre) sebbene sia assente la merlatura. La torre della Vignazza inoltre conserva integro l’ingresso, largo 0,50 m. circa e sorretto dal caratteristico architrave monolitico in pietra lavica. Purtroppo quest’ultima struttura, dopo svariati decenni di abbandono, è stata oggetto di pesanti restauri, che hanno del tutto nascosto la muratura, coperta sotto uno spesso intonaco grigiastro. E’ evidente che tali torri fossero il risultato di un’idea edilizia comune ed evidentemente di esigenze diffuse tanto nell’entroterra etneo, quanto lungo la costa. Dovevano svolgere una doppia funzione: di vedetta e di luogo ove presumibilmente stipare derrate alimentari. In effetti queste strutture non posseggono affatto caratteritiche simli alle contemporanee torri di Deputazione, la cui edificazione fu il risultato di un piano ben studiato, rivolto alla difesa delle coste siciliane. Al fine di porre in atto un’opera tanto dispendiosa, vennero dalla Toscana due architetti, Camillo Camilliani [C. Camilliani 1877] e Tiburzio Spannocchi [T. Spannocchi 1993]. Il loro compito, di difficile attuazione, fu quello di una lunga ricognizione dei tre litorali dell’Isola, per scoprire luoghi adatti per edificare grandi torri di avvistamento. Esse avevano caratteristiche comuni: base scarpata, all’interno della quale vi stava solitamente una cisterna; primo piano a pianta quadrangolare e segnato da marcapiano; infine terrazza ove solitamente sostava un piccolo cannone. Le torri di Deputazione, infatti, funzionavano come veri e propri fortini, collegati fra loro, ma virtualmente indipendenti: avevano l’importante compito di difendere, anche a colpi di cannone, le coste dai frequenti sbarchi di pirati turchi Dunque caratteristiche diverse rispetto alle torri oggetto di studio. La differenza si spiega in base allo scopo per il quale vennero edificate. La torre dell’Acquafredda non doveva cannoneggiare nessuno, eventualmente avvertire i vicini abitanti delle campagne di possibili pericoli imminenti: incendi, briganti, eventuali pirati, tanto ardimentosi da spingersi cosi in profondità verso l’entroterra. E trattandosi di torri probabilmente private, desta interesse l’identità del progetto: ovunque si trovino edifici del genere, essi presentano sempre caratteristiche comuni. Ciò lascia incuriositi, poiché nel caso di torri private edificate lungo le coste dell’isola, questa identità di progetto non si riscontra. Sia il Camilliani, quanto lo Spannocchi descrivono torri baronali sempre diverse, una a pianta quadrangolare, un’altra a pianta circolare, tutte con dimensioni dissimili. Evidentemente le torri granaio edificate lungo l’Alcantara, nella loro identità strutturale rispondono a particolari esigenze, non ultime quelle prettamente legate alle attività rurali. In ultima analisi si consideri il caso dell’abitato ionico-etneo di Giarre. L’insediamento dovrebbe sorgere intorno alla metà del XVI sec. come centro di raccolta delle derrate alimentari prodotte dalle attività agricole esistenti nella zona. Poco prima dei moti rivoluzionari per l’unità d’Italia, al centro del paese sorgeva una torre. Ai giorni nostri di tale struttura nulla rimane, perché devastata dalla furia popolare del 1848. Fortunatamente dell’edificio turrito esiste una piccola rappresentazione pittorica, operata dalla mano di un pittore acese del settecento: Tuccari. Certamente la pittura stilizza l’antico centro storico di Giarre, ma la torre viene rappresentata similmente a quella dell’Acquafredda o della Vignazza presso Giardini Naxos: si ipotizzano infatti i tre piani, si legge chiaramente la pianta quadrata, la copertura a doppio spiovente e la posizione delle finestre simile a quanto si può osservare nelle strutture ancora esistenti. Pur non avendo una testimonianza architettonica diretta, si può affermare che l’antica torre di Giarre era una torre granaio, del tipo ampiamente esposto in queste pagine. La sua presenza non stupisce, poiché la vocazione dell’abitato fin dalla sua nascita era proprio quella agricola. Si sconosce il numero di tali strutture esistenti o esistite nell’area etnea. Studiarne la presenza e la diffusione potrebbe realmente aiutare la comprensione delle attività economiche e in generale della società siciliana del XVI e XVII sec. Infine, riguardo all’edificazione di tali strutture, non si sottovaluti la possibile influenza della famiglia Lanza, dei cui effettivi possedimenti terrieri, certamente vasti, non possediamo una completa conoscenza.
Giuseppe Tropea da medioevosicilia.eu.
Pagina Etnanatura: Torre Acquafredda.
Foto di Salvo Nicotra
La timpa di Acireale
 Quello che vi proponiamo è un percorso nel tempo e nello spazio che si sviluppa lungo la timpa di Acireale. Andremo molto a ritroso nel tempo visto che geologicamente la timpa si è formata oltre 200.000 anni fa. Il percorso nello spazio, da sud a nord, da Capo Mulini a Stazzo è più breve ma ci permetterà di riconoscere uno dei posti più affascinanti dell’Etna malgrado in alcuni punti abbia subito lo stupro volgare e violento dei palazzinari.
Quello che vi proponiamo è un percorso nel tempo e nello spazio che si sviluppa lungo la timpa di Acireale. Andremo molto a ritroso nel tempo visto che geologicamente la timpa si è formata oltre 200.000 anni fa. Il percorso nello spazio, da sud a nord, da Capo Mulini a Stazzo è più breve ma ci permetterà di riconoscere uno dei posti più affascinanti dell’Etna malgrado in alcuni punti abbia subito lo stupro volgare e violento dei palazzinari.
Geologia. Fase delle Timpe: a partire da almeno 220.000 anni fino a circa 110.000 anni fa l’attività eruttiva si concentra lungo la costa Ionica in corrispondenza del sistema di faglie dirette denominato delle Timpe che rappresenta la prosecuzione settentrionale della Scarpata Ibleo-Maltese nella regione etnea. Le faglie delle Timpe costituiscono delle imponenti scarpate morfologiche che formano il tratto di costa da Capo Mulini fino ad Acireale, sviluppandosi in direzione NNO fino alla zona di Moscarello-S. Alfio. Durante questa fase si verificarono numerose eruzioni fissurali che si localizzavano prevalentemente lungo questa ristretta fascia allungata lungo la costa Ionica. La continua sovrapposizione delle colate laviche in quest’area ha portato nel tempo alla formazione di una prima struttura vulcanica di tipo scudo estesa per almeno 22 km in direzione NNO. La struttura interna di questo vulcano a scudo è oggi esposta lungo le scarpate di faglia delle Timpe fra Acireale e Moscarello. Durante questo lungo periodo eruttivo si verificavano anche sporadiche eruzioni fissurali lungo la Valle del Fiume Simeto fino alla costa. Testimoni di queste eruzioni sono il grosso cono di scorie che costituisce la collina di Paternò e diverse sottili colate laviche fortemente erose come quelle affioranti nella periferia nord di Catania in località leucatia-fasano. Fra circa 129.000 anni e 126.000 anni l’attività eruttiva di tipo fissurale si sposta verso ovest interessando per la prima volta l’area centrale della regione etnea fra la Val Calanna e la Timpa di Moscarello. Complessivamente l’attività vulcanica della fase Timpe termina circa 110.000 anni fa. (1)
Fauna e flora. A popolare la riserva naturale della Timpa sono numerose specie di animali, che, grazie anche al difficile accesso da parte dell’uomo, trovano un habitat ideale. Nell’area protetta vivono infatti conigli selvatici, ricci, volpi che coabitano insieme a rettili come i colubri leopardini e le lucertole campestri. A causa degli incendi estivi alcune specie di rettili sembrano scomparse: è il caso della tartaruga terrestre. Non mancano caratteristiche specie di volatili. Di giorno è possibile osservare in volo il falco pellegrino, il gheppio e la poiana, mentre di notte comuni rapaci sono l’assiolo, il barbagianni e la civetta.. Lungo le coste è notevole la presenza di gabbiani, meno frequente in autunno quella del cormorano. Con l’arrivo delle calde temperature giungono dall’Africa la rondine e l’upupa che depongono qui le loro uova. Molte specie come lo scricciolo e il merlo, invece, si incontrano tutto l’anno, soprattutto nelle zone in cui è presente la macchia mediterranea e nei limoneti. Ricchi di vita sono pure i fondali del mare della Timpa, anch’essi di origine vulcanica. I fondali sono lavici sino a circa -30 metri, poi diventano sabbiosi e, oltre i -50-60 metri, prevalentemente argillosi. A volte sono presenti delle piccole secche di blocchi lavici arrotondati. Nelle cavità dei fondali vulcanici trovano rifugio Polpi e Murene. Nella zona più illuminata dai raggi solari sono presenti diverse specie di Cystoseria e di Sargasso. I fondali sono molto ricchi di alghe calcaree libere (Melobesie). Esistono circa 300 tipi di alghe appartenenti alle Rhodophyta (alghe rosse), Clorophyta (alghe verdi) e Phaeophyta (alghe brune). Tra i pesci non è difficile incontrare giovani Monacelle, branchi di argentei Bianchetti, Ope e Salpe. I fondali della Timpa sono inoltre famosi per la ricchezza di molluschi come gli Occhi di bue e i Ricci di mare. Tra i crostacei sono comuni varie specie di granchi e paguri e più in profondità troviamo delle aragoste. Un meraviglioso spettacolo offrono le pareti superficiali a strapiombo colonizzate da centinaia di coralli gialli e rosa (2). La flora è principalmente caratterizzata da arbusti o piccoli alberi sempreverdi e sclerofilli (a foglie coriacee). la vegetazione è solitamente resa densa e compatta dall’intreccio di numerose piante rampicanti. la densa vegetazione limita la filtrazione di luce al suolo, riducendo grandemente il numero di piante erbacee presenti. La zona di riserva integrale è caratterizzata da una lunga parete rocciosa, ricoperta da vegetazione spontanea in buona parte incontaminata, mentre la zona di preriserva, un tempo coltivata a mandorlo olivo, carrubo e ficodindia, è oggi quasi esclusivamente occupata dai limoneti, coltivati sulle terrazze costruite con i muretti a secco in pietra lavica.la zona della preriserva è caratterizzata da vegetazione arbustiva sempreverde come l’euphorbia dendroides. Altre specie arbustive presenti sono l’anagyris fetida, l’artemisa arborescens, il rhamnus alaternus. le specie arboree sono il carrubo ed entità non autoctone, propagatesi ad opera dell’uomo. Lungo la fascia litoranea che interessa la riserva, si trovano specie erbacee ad alta specializzazione che ben resistono a un ambiente con notevole siccità del suolo, dovuta alla salsedine, fra le quali il finocchio di mare. Nella zona nord si riscontano resti di quello che fu il bosco di Aci, una vasta area caratterizzata da vegetazione arborea (3).
Geografia. Iniziamo la nostra passeggiata virtuale da Capo Mulini nella propaggine sud della timpa. Vi avvertiamo che se il percorso proposto sarà continuo nello spazio (da sud a nord), non altrettanto possiamo garantirvi per la storia. Ritroveremo tracce della nostra storia dai romani, ai normanni per arrivare agli inizi del secolo scorso.
Capo Mulini. Almeno fino agli anni 50 del nostro secolo, Capo Mulini (vedi) si prefigurava alla maniera di una piccola borgata marina, composta da poche decine di abitazioni di forma settecentesca, disposte intorno ad un piccolo edificio di culto. In effetti ancora oggi il paese si distribuisce lungo due arterie stradali principali, perpendicolari alla costa, sebbene pochi siano i resti risalenti al XVII/XVIII, per la maggior parte soppiantati da costruzioni moderne. Un tempo si addossavano l’un l’altro piccoli edifici, all’interno dei quali si conciava la pelle, probabilmente con l’ausilio di mulini, che un tempo donarono il toponimo al borgo e dei quali oggi non rimane in pratica nessuna traccia. Alcuni ruderi interessanti è possibile osservarli nei pressi del moderno edificio di culto, per l’esattezza ad oriente di quest’ultimo. Trattasi, probabilmente, dei resti di una precedente chiesa, diruta e quasi del tutto obliterata da un cataclisma non ben individuato, forse un terremoto o un maremoto corrispondente al terribile terremoto, che colpì Messina nel 1908, il quale causò ripercussioni lungo tutta la costa ionica, almeno fino a Catania. Nei presi di siffatti ruderi giacciono, inoltre, i resti basamentali di un tempio romano del I/II secolo d.C. Studiati a fondo dal Libertini, durante la metà degli anni 50, purtroppo ai giorni nostri non sono visitabili, perché giacenti in territorio privato e non vincolati. I resti constano di un basamento edificato per una parte con malta cementizia e pietrame lavico non sbozzato; una seconda porzione invece sembra presentare, almeno all’esterno, grossi blocchi di basalto incastrati l’un l’altro e legati insieme dalla medesima malta. A settentrione del basamento il Libertini vedeva una sorta di sacello o una camera ipogeica, oggi ancora presente ma del tutto interrata. Un’altra struttura interessante sembra preservarsi nei pressi del porto. Essa per forma e consistenza pare essere una fortezza costiera risalente al XVI/XVII secolo, similmente alla vicina “Fortezza del Tocco”, sita nei pressi di S. Maria la Scala. In effetti la tecnica edilizia del bastione murario, ad emplecton, cioè a rivestimento esterno con grossi conci di pietra lavica e anima interna di pietrame minuto e malta pare proprio antica. Inoltre il taglio a cuspide del bastione murario perpendicolare alla costa lascia veramente credere all’esistenza, in questo luogo, di una fortezza costiera, edificata a protezione della costa, contro gli assalti dei pirati turchi. Confermerebbe l’ipotesi anche il fatto che solo Capo Mulini non presenterebbe strutture fortificate del genere, rispetto a tutti gli altri abitati costieri, i quali, al contrario, ancora ai giorni nostri conservano i ruderi di fortificazioni costiere risalenti al XVI/XVII secolo. (10)
Il tempietto di Capo Mulini. Pochi sanno che a CopoMulini si trovano i resti basamentali di un tempio romano del I/II secolo d.C (vedi). Studiati a fondo dal Libertini, durante la metà degli anni 50, purtroppo ai giorni nostri non sono visitabili, perché giacenti in territorio privato e non vincolati. I resti constano di un basamento edificato per una parte con malta cementizia e pietrame lavico non sbozzato; una seconda porzione invece sembra presentare, almeno all’esterno, grossi blocchi di basalto incastrati l’un l’altro e legati insieme dalla medesima malta. A settentrione del basamento il Libertini vedeva una sorta di sacello o una camera ipogeica, oggi ancora presente ma del tutto interrata. Alcuni pietre del tempio sembra che siano state prelevate per costruire in epoca sveva le mura di difesa ancora visibili nel porto della contrada.
Torri Alessandrano e sant’Anna. Per proteggere il porto dalle scorribande dei pirati furono edificate le due torri Alessandrano e Sant’Anna (vedi). La Torre Sant’Anna, fu iniziata nel 1582 in corrispondenza del Capo Mulini e finita in circa un ventennio. Vi alloggiava un corpo di guardia con il compito di allertare all’avvicinarsi di navi corsare. Nel 1868 la torre di Sant’Anna venne convertita in faro. Oggi si trova in una proprietà privata.
Gazzena. La contrada della Gazzena (vedi) è certamente una delle aree più interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Il nostro sentiero si dirige attraverso una tipica stradella di campagna (rasula) verso un magazzino abbandonato che si erge sull’altura, accanto al quale si sviluppa un sentiero verso nord che in breve tempo condurrà su un’altra rasula, lunghissima e ben conservata, con a lato un caratteristico canale di irrigazione (saia). Percorrendola fino in fondo in direzione est, troveremo un edificio in rovina che accoglie un pozzo
ed i resti di un macchinario a vapore che serviva al sollevamento dell’acqua destinata ad irrigare l’agrumeto e gli orti situati nel pianoro sottostante: essendo oggi tutta l’area coltivabile in completo abbandono, sarà possibile osservare le varie fasi della ricostituzione della originaria macchia mediterranea. Superato il pozzo ci si affaccia su un primo gradino della timpa della Gazzena: qui il terreno presenta due scarpate di faglia parallele che creano altrettanti ripiani degradanti. Restando nel ripiano alto e percorrendo il margine verso nord per quasi 100 metri, si raggiunge un casolare abbandonato al cui fianco sorge un popolamento di Sommacco, pianta un tempo utilizzata per la concia delle pelli. Da qui inizia la discesa per un ripido sentiero tortuoso dove, su una lastra lavica, si osservano simboli incisi e l’iscrizione: “Arcangelo Calanna beneficò questa terra l’anno del Signore 1868”. Attraversato il pianoro ci si può affacciare sull’orlo della seconda faglia e si apre il dirupo della timpa marina: macigni di lava, anfratti e insenature, vegetazione. Più sotto, il mare. Parallelamente al bordo della scarpata si trova un viottolo che costeggia l’antico muro a secco con le caratteristiche pietre “paralupo”. Alla fine del tracciato si giunge alla spianata, in leggera salita, che si dirige verso una costruzione (la Casazza) recentemente ristrutturata, circondata da una ricca boscaglia a Roverella. Questa costruzione può essere raggiunta, in alternativa, da una rasula seminascosta dalla vegetazione che si sviluppa sul bordo del sopraccennato primo gradino ad una quota di circa 60 m sul livello del mare. La via del ritorno sarà un percorso in parte diverso da quello dell’andata: ritornando verso il pianoro si scorge sulla destra un largo sentiero carrozzabile che risale il pendio e conduce ad una maestosa dimora patrizia (Villa Calanna) che oggi è in stato di completo abbandono, ma rappresenta comunque un gioiello di architettura rurale. Un sentiero che si sviluppa verso sud-est ricondurrà al magazzino abbandonato dal quale si è intrapresa l’escursione. (4)
Villa Calanna. Villa Calanna (vedi) La Villa fu costruita a più riprese nel corso del XIX secolo, comprende oltre alla residenza signorile, palmenti, frantoio, stalle e imponenti cantine. La residenza (edificata tra il 1856 e il 1860), ha carattere signorile, le sue stanze sono pavimentate a cotto e controsoffittate con volte ad incannucciato elegantemente dipinte, le aperture a porta-finestra hanno cornici in pietra calcarea. (5)
Acque Grandi. Il sentiero delle Acquegrandi (vedi) o Acquaranni attraversa uno tra i più integri tratti della Timpa di Acireale. Il suo imbocco si trova affiancato alla chiesetta della Madonna dell’Aiuto (riedificata tra il 1769 ed il 1773) che si apre sulla via omonima. Quest’ultima è una stretta stradella rurale raggiungibile dalla frazione di Santa Caterina o da Santa Maria delle Grazie, delimitata da alti muri in pietra lavica. Sulla facciata della chiesetta spicca la scritta Auxilium Cristianorume sul suo fianco settentrionale c’è una stradella dal fondo asfaltato. È questo l’inizio del sentiero che porta alle Acquegrandi fra alti muraglioni a secco coperti da Bagolaro, Eucalipto, Alaterno, Ulivo domestico ed Edera arborescente. Superato un cancello metallico aperto la stradella diventa un viottolo. Dopo l’incontro con un monumentale esemplare di Roverella, si giunge su un falsopiano che si affaccia quasi a picco sulla scarpata sottostante e che offre un’estesa visuale sul mare: a destra la spiaggia diAcquegrandi ed a sinistra i declivi della Timpa di Don Masi, dove sono presenti la Roverella, l’Olivastro e popolamenti di Cannuccia del Reno (Arundo pliniana). È un eccellente punto di osservazione per l’avifauna. Nei pressi del pianoro, doveva localizzarsi uno dei punti di avvistamento distribuiti sul litorale ai tempi delle incursioni piratesche. Troviamo inoltre un cippo commemorativo dedicato al giovane Matteo Mustica, sub catanese deceduto per embolia nel sottostante specchio d’acqua. Ci si incamminerà verso il mare per uno scosceso sentiero a gradini in pietra che attraversa la scarpata con punti di dislivello accentuato e si immerge nel paesaggio consentendo di osservare aspetti tipici di vegetazione (Olmo, Bagolaro, Alaterno, Euforbia, Fico d’India, Asparago pungente, Garofanino delle rocce), nonchè spaccati geologici di notevole interesse. Giunti sulla spiaggia, ampia ed estesa per alcune centinaia di metri, formata essenzialmente da pietre arrotondate dalla azione marina (coculi), è probabile rinvenire la sorgente a fior d’acqua che dà il nome al luogo: è di portata variabile, una volta copiosa (da cui il nome ranni = grande). Spostandoci verso nord, sulla battigia si osservano grandi macigni alveolati per corrosione dei sali marini e diverse specie vegetali costiere (Violaciocca, Cappero, Spinasanta, Finocchio di mare). Dopo circa 200 metri (ma è assai difficoltoso giungervi via terra) troveremo un significativo giacimento fossilifero. (6)
Santa Caterina e Acqua Ferro. Santa Caterina (vedi https://www.etnanatura.it/sentieri/sentieri.php?nome=Santa_Caterina) è un borgo acese che si sviluppa tra tipiche viuzze e giardini di limoni. Sul lato settentrionale del Belvedere di Santa Caterina si intravede una piccola strada (via Acqua del Ferro) che attraversa un gruppetto di ville e poi scende verso la sottostante costa, dove si trova una sorgente d’acqua dolce denominata Acqua ‘o ferru. Il percorso si sviluppa attraverso una ripida e poco agevole scalinata composta da 392 scalini, ai lati della quale è possibile osservare alcuni alberi di Carrubo e arbusti ed erbe tipiche dell’ambiente mediterraneo. Fatti i primi 277 gradini (115 in salita) potremo riposarci su un ripiano ombroso (per la presenza di un rigoglioso Caprifico) sul quale c’è una piastra marmorea che reca la scritta: Dedicata a Pina – 1989. Dinnanzi avremo un gruppo di rocce laviche nel caratteristico aspetto colonnare. Continuando la discesa giungeremo in riva al mare. Qui ritroviamo una piccola sorgente Acqu’e ferru dal caratteristico colore rossiccio, causato dalla presenza di ossidi di ferro, che nella fantasia popolare, sulla base dei versi ovidiani, viene attribuito al sangue di Aci. (7)
Pietra Monaca. La località Pietra Monaca (vedi) è un altro dei luoghi della Timpa in cui affiora una sorgente d’acqua dolce. Si trova fra le sorgenti dell’Acqua del Ferro e quelle di Miuccio, in corrispondenza del popoloso quartiere acese del Carmine. Proprio da qui partivano le lavandaie con il voluminoso fagotto di panni (truscia) da lavare, caricato, in bilico, sul capo. Esse imboccavano alcune traverse della via e si portavano su di un ponte che consentiva di superare la linea ferrata Messina-Catania, allora ad un unico binario; da qui si immettevano dapprima su una stradella in leggera pendenza, che era fiancheggiata da agrumeti, e poi scendevano alla marina mediante un ripidissimo sentiero che le portava alla meta. Sia la stradella che il sentiero, originariamente denominati Passu di jusu, presero il nome di via Pietra Monaca dall’esistenza di un macigno che ricordava le sembianze di una monaca coricata. Oggi il percorso ha cambiato sembianze. Nella prima metà degli anni ’60 del XX secolo la costruzione della nuova strada statale 114 interruppe il collegamento fra Acireale e la via Pietra Monaca, poi risolto mediante la costruzione di un sottopassaggio. Negli anni ’70 il raddoppio del binario della linea Messina-Catania, portò alla dismissione della vecchia ferrovia ed alla eliminazione dell’accesso al sottopassaggio appena costruito. Nel tentativo di salvare il ricongiungimento fra Acireale e la via Pietra Monaca fu realizzato un rocambolesco percorso che costeggia il terrapieno della nuova sede ferroviaria: si presenta oggi quasi sempre impraticabile. Chi oggi volesse giungere alle sorgenti della Pietra Monaca o semplicemente ammirare dall’alto il costone su cui si sviluppava la parte estrema del percorso sopraccennato potrebbe usare l’alternativa di via Pianetto (che si apre nei pressi dell’hotel Aloha D’oro). Questa stretta strada conduce dapprima su uno spiazzo panoramico che si affaccia sulla Timpa. Qui avremo un’ampia visuale della costa e del mare sottostante, insieme però all’orribile visione dello scheletro cementizio di una struttura alberghiera iniziata negli anni ’70 e mai completata. Nelle vicinanze troviamo alcune case rurali ed un edificio privato, la “Villa Lina”. Da qui cominciano due sentieri. Andando verso nord è possibile percorrere un breve viottolo senza sbocco, nello splendore della vegetazione mediterranea. Altrimenti è possibile seguire il ripidissimo sentiero verso il mare, oggi difficilmente praticabile per il degrado del tracciato, un tempo costituito per lunghi tratti da scalette in pietra lavica e camminamenti. Giunti sulla battigia si riconoscerà affiorare tra gli scogli, a pochi metri dal mare, quello che probabilmente è l’unico esemplare spontaneo di Tamerice presente lungo il litorale acese. (8)
Chiazzette. L’itinerario delle Chiazzette (vedi) è il più accessibile per chi desidera visitare la Riserva ed offre splendidi panorami sulla costa ionica. Oggi provenendo dalla via Romeo, bisogna attraversare il ponte sulla Nazionale. La stradella (oggi denominata via Tocco), composta da sette tornanti, si snoda dalla città di Acireale giù fino al borgo marinaro di Santa Maria la Scala consentendo di superare comodamente il dislivello di 150 metri. La stradella fu riassettata nel secolo XVII su di un preesistente tracciato, realizzando particolarissimi muri di sostegno ad arco e rampe larghe fino a sei metri; per oltre due secoli fu la principale via di collegamento fra Acireale e il sottostante borgo ricco di sorgenti d’acqua dolce e sede di un porticciolo. All’ingresso (sulla Panoramica) c’è una breve scalinata affiancata da un corto scivolo. Corredano la stradella acciottolata alcuni esemplari di Robinia pseudoacacia, relitti dell’antica alberatura, a doppio filare, originariamente costituita da circa 400 alberi. La prima “piazzetta” è dominata da un monumentale esemplare di Platano la cui età è sicuramente da stimare oltre i 150 anni. Superata la curva ci si incammina sulla prima rampa delle Chiazzette, sul cui sfondo si staglia la Fortezza del Tocco: il bastione, edificato a fini difensivi nella prima metà del XVII secolo, è oggi sede del Centro Visite dell’area protetta. Da qui è possibile ammirare un ampio tratto di costa. Lungo la quarta rampa si trova la appella dedicata al SS. Crocifisso della Buona Nuova, risalente alla prima metà dell’ottocento. Sulla settima ed ultima rampa vi sono due alternative: andando dritto si raggiunge la piazza del borgo marinaro, mentre imboccando il sentiero sulla destra, denominato via Miuccio, si giunge preso l’omonima spiaggia. Il percorso che conduce nella piazza principale del paese, dove si trova la Chiesa Madre, è quello originario: costeggia a valle l’abitato e, a monte, i contrafforti della Timpa, lungo cui si aprono gli ingressi di alcune abitazioni. La seconda alternativa scende a zig zag verso la costa con 18 stretti e corti tornanti privi di parapetto e lungo i quali incontriamo vari alberelli di Bagolaro. Il percorso giunge in un ampio piazzale detto del Miuccio, dove si trova il Mulino Testa dell’Acqua. La sorgente che alimentava il mulino, in tempi recentissimi, è stata imbrigliata in una presa d’acqua, e le strutture metalliche stridono con il paesaggio circostante. Superatele si accede alla particolare spiaggia di “cocole” del Miuccio. Lungo tutto il percorso delle Chiazzette si osserveranno alcune piante tipiche della Riserva: oltre al Cappero e al Bagolaro, troviamo l’Euforbia arborea, l’Alaterno, l’Ailanto (specie esotica invasiva), il Terebinto e il Fico d’india. Ma singolare è il rigoglioso popolamento spontaneo di un’altra specie esotica: il Gelso da carta o Broussonezia, importata dal Giappone nel XVIII secolo come albero da ombra, mentre, nel paese d’origine, essa viene coltivata a scopo merceologico, in quanto dalla sua corteccia si ricava un particolare tipo di carta assai resistente impiegata per la stampa delle banconote. (9)
Fortezza del Tocco. All’inizio del sentiero delle Chiazzette si ritrova la Fortezza del tocco (vedi). Dopo la battaglia di Lepanto si intensificarono le scorrerie turche sulle coste italiane. Acireale venne interessata nel 1582 dal tentativo di sbarco del pirata Luccialì con al seguito sette galee turche nei pressi di Santa Tecla. Il tentativo di sbarco, che venne contrastato e respinto dalla mobilitazione della popolazione, spinse comunque la città a dotarsi di un sistema di difesa dalle scorrerie. Così alla fine del XVI secolo vennero intraprese alcune importanti opere di fortificazione da parte degli spagnoli nel litorale di Acireale, fra cui la Torre Alessandrano e la quadrangolare Torre di Sant’Anna nel borgo di Capo Mulini (1585), la Garitta di S. Tecla e la Fortezza del Tocco (Fortezza seu Bastione) sulla Timpa di Santa Maria La Scala (1592-1616). Le opere si andavano ad innestare in quello che fu il sistema di fortificazioni federiciane, d’epoca sveva, in quello che divenne quindi il sistema difensivo delle Torri costiere della Sicilia. Santa Tecla, la garitta dello “Scalo Pennisi” (XVI secolo). La Fortezza del Tocco venne progettata dall’ingegnere Camillo Camilliani, nella Timpa di Acireale e realizzata dall’ingegnere acese Vincenzo Geremia – detto porcellana. A Geremia si deve, nel 1624, l’aggiunta di un cannoncino portatile. La Fortezza. Nel 1626 vennero eseguiti altri lavori di ampliamento, da alcuni condannati per lavori forzati. Il forte, da cui si gode un ampio panorama sulla costa era a pianta irregolare ed ospitava un grande cannone che, sparando un colpo ad ogni avvistamento di navi pirata, avvertiva la popolazione del pericolo. Nel 1675 la torre venne utilizzata come piazzaforte militare per il cannoneggiamento della flotta francese, che stava cercando di aggirare il blocco composto dalla città e dall’esercito spagnolo durante la guerra franco-spagnola. Nel XIX secolo finite le esigenze difensive il forte fu dismesso ed abbandonato. Il cannoncino portatile sarà tolto nel 1834 e spostato alla Pinacoteca Zelantea, dove è oggi visitabile.
Santa Maria la Scala. Il borgo di Santa Maria la Scala (vedi) si trova sulla costa ionica ai piedi della Timpa,una gigantesca falesia riccamente stratificata, a circa 3 chilometri di strada rotabile da Acireale, di cui costituisce il più prossimo sbocco a mare. Gli abitanti sono localmente conosciuti con il nome di scaloti. La chiesa parrocchiale è del XVII secolo. L’abitato, sovrastato dalla Timpa su cui, a 140 m s.l.m., è posta Acireale, si raccoglie attorno al porticciolo detto Scalo Grande, allungandosi sull’angusto lungomare verso sud dove sorgono alcune interessanti costruzioni per la villeggiatura di fine Ottocento della borghesia acese. All’estremità meridionale della frazione vi è un mulino,detto di Miuccio documentato a partire dal sec.XVI, già ad acqua, alimentato dalla sorgente di Testa dell’acqua che sgorga a pochi metri dal mare dalle viscere della Timpa che è di notevole rilevanza naturalistica. A nord dell’abitato, accessibile via mare, si trova la Grotta delle palombe , un complesso di basalti colonnari parzialmente frantumato dalle mareggiate.Nel 1972 così si è inabissato il caratteristico pugno che si ergeva nello specchio di mare chiuso a sud dalla pietra delle sarpe. Secondo la fantasia popolare era il rifugio amoroso del pastore Aci e della ninfa Galatea.
Miuccio. Il borgo di Santa Maria la Scala è ricco di sorgive che sgorgano al mare. Uno dei ruscelletti alimenta il mulino di Miuccio (vedi) che deve il nome alla famiglia proprietaria dell’immobile. Il sito è di un fascino incredibile anche se deturpato dallo scheletro di un albergo mai costruito. Si spera che, come promesso da molti anni, prossimamente si possa procedere alla demolizione di questo eco mostro.
Grotta delle Palombe. A nord dell’abitato di Santa Maria la Scala, accessibile via mare, si trova la Grotta delle palombe (vedi) , un complesso di basalti colonnari parzialmente frantumato dalle mareggiate.Nel 1972 così si è inabissato il caratteristico pugno che si ergeva nello specchio di mare chiuso a sud dalla pietra delle sarpe. Secondo la fantasia popolare era il rifugio amoroso del pastore Aci e della ninfa Galatea. Secondo un’altra leggenda la grotta fu di una ninfa, Ionia, che aveva cura dei colombi che ogni inverno si rifugiavano in questa grotta. Purtroppo altre ninfe invidiose ne ostruirono l’entrata facendo morire i colombi e suscitando la disperazione di Ionia che con un grido fece crollare la grotta rimanendo seppellita insieme ai suoi amici.
Grotta santa Maria della neve. Sulla strada provinciale che scende verso il mare, a breve distanza dalla Villa Belvedere, si erge una minuscola chiesetta dal nome suggestivo che rievoca tempi e fatti avvolti nella leggenda anche se storicamente collocati a metà del ’700. L’antichissima grotta lavica (vedi), parte integrante dell’attuale chiesetta, che curiose leggende dipingevano come ricettacolo di ladri e assassini o addirittura dimora di demoni ed orride bestie, fu in verità adibita da qualche pastore della zona a ricovero per le capre, o scelta come rifugio provvisorio da qualche “discursore di campagna” nell’attesa di assalire malcapitati viandanti che solitari si avventuravano per quel sentiero. Nel 1752 un pio sacerdote, don Mariano Valerio, per adempiere ad un voto pensò di tramutarla in chiesa con l’intento di esporvi un presepe e ricordare così la nascita di Gesù. Per l’occasione, scrisse pure una collana di sonetti in dialetto siciliano da recitarsi davanti al presepe della Grotta ogni mese. Morto il Valerio, divenne Rettore della chiesa il can. Pasquale Pennini che nel 1820 ampliò la grotta costruendo un pronao con tre colonne e abbellì il prospetto in pietra bianca su cui spiccano i componenti della Sacra Famiglia, ben visibile dal mare di S. Maria La Scala. Qualche anno prima che la chiesetta subisse questi restauri, fu dato l’incarico di rinnovare il presepe ad un bravo artigiano acese, Mariano Cormaci, il quale si era messo in luce avendone costruito uno bellissimo nella chiesa madre di S. Venerina. Il Cormaci,attivo tra la fine del ‘700 e la prima metà dell’800, verso il 1812 plasmò nella cera, insieme allo Zammit, conosciuto come “ u nuticianu” perché proveniente da Noto, e al romano Santi Gagliani, le teste dei pastori; le mani, invece, furono intagliate nel legno ed inseriti in manichini rivestiti con varie stoffe, a seconda del ruolo dei personaggi che risultarono quasi a grandezza naturale. Le stoffe dei vestiti, ad eccezione delle sete e dei damaschi con ricami in oro dei Re Magi, rovinate purtroppo dal tempo, sono state rinnovate, mentre le barbe ed i capelli dei pastori sono ancora gli stessi donati dai fedeli come ex voto. Gli animali presenti sulla scena, pecore e conigli, sono stati modellati in gesso. Per questi lavori eseguiti con tecniche raffinate e con risultati artistici veramente sorprendenti, il Cormaci ricevette un compenso annuo di onze due e tarì 15, poca cosa per un lavoro così ben fatto. Si disse – ma è solo una diceria – che per modellare quelle teste l’artista avesse usato una tecnica segreta, poiché i successivi restauri non riuscirono ad imitare la tecnica conosciuta solo da sua nipote: in seguito alcuni volti furono rinnovati in gesso o in cartapesta con risultati meno apprezzabili, tanto che nei restauri del 1984 sono stati accantonati. Le figure sono di un realismo impressionante e formano un’interessante tipologia popolare e un ricco campionario di costumi dell’epoca. Lo spettatore, colpito dalla dolcezza dell’evento narrato a cui partecipa la natura tutta, è attratto da “Jnnaru”, coperto di stracci, contento di stare a scaldarsi davanti al braciere. Tra i personaggi tipici ricordiamo anche il Suonatore di cornamusa, lo Spaventato della grotta, i numerosi contadini – belli, dolci, estatici – che recano in dono ceste di arance, fiscelle di ricotta ed altre umili cose che poveri pastori “alla campìa” potevano offrire a Gesù appena nato. Tutti fanno da corona alla Sacra Famiglia: a fianco a Maria che osserva estasiata la sua Creatura con un sguardo materno pieno di dolcezza c’è S. Giuseppe, pensoso, appoggiato al suo bastone; e tutti sembrano cantare, per celebrare la sacralità della vita, il terzo “mistero gaudioso” nel colorito dialetto:
Parturistuvu Gran Signura
‘nta ‘na povera mangiatura:
e nasciu Gesù Bammineddu,
‘mmenzu ‘nvoi e ‘n’asineddu.
Sul finire dell’800, la chiesetta che intanto aveva preso pure il nome di S. Maria della Neve, restò chiusa per qualche anno, ma a partire dal 1900, grazie all’interesse della nobildonna M. Serafina Pennisi, erede dei Valerio, fu riaperta al pubblico per le festività natalizie con la celebrazione di una messa presieduta dal vescovo mons. Genuardi. Nel 1984 la Sovrintendenza per i beni culturali di Catania ha restaurato ogni componente del Presepe facendo sì che fosse cancellata l’usura del tempo e la violenza di discutibili restauri precedenti. All’ingresso, sulla stretta parete del pronao fa bella mostra di sé la splendida pala d’altare di Vito D’Anna raffigurante la “Natività”, forse dipinta nel 1740, dal pittore palermitano poco più che ventenne negli anni in cui frequentava la bottega del nostro Paolo Vasta, i cui influssi sono evidenti. Delicato il volto della Madonna, ricche le vesti della giovane donna che invita il figlioletto a rendere omaggio al Bambino Gesù mentre sullo sfondo, nella penombra, S. Giuseppe manifesta la sua ieratica, discreta presenza a così grande mistero. (11)
Timpa Falconiera. La Timpa di Santa Tecla o Falconiera (vedi) va dalla località Grotte di Acireale alla contrada Mortara, nei pressi di Santa Maria Ammalati. La sua base, contrariamente alle altre porzioni della Timpa, non è a diretto contatto con il mare, ma al di sotto di essa si estende una spianata (Pedi ‘i Timpa) in cui si sviluppa un’area coltivata a limoni e vi è insediato il borgo marinaro di Santa Tecla. La vegetazione naturale si è qui ben conservata nei terreni a ripida pendenza solcati da naturali canaloni (lavanara) formati dal deflusso delle acque, mentre le superfici più accessibili furono messe a coltura con lavori di dissodamento (scatinu) e di sistemazione con terrazzamenti (custeri) in pietra lavica. La linea ferroviaria dismessa offre l’opportunità di attraversare longitudinalmente la Timpa di Santa Tecla consentendo una vera e propria immersione in questa parte della Riserva. Il vecchio tracciato ferroviario è una tratta della ferrovia statale a binario unico costruita nella seconda metà del secolo XIX e disattivata negli anni sessanta in seguito alla realizzazione del nuovo tracciato a doppio binario in galleria a monte della medesima. Il tratto in disuso prende avvio da località Grotte e termina presso la contrada Mortara, accanto alla nuova strada ferrata. Tutto il percorso, lungo circa 3 Km (cioè per l’intera estensione della Timpa di Santa Tecla) si presenta perfettamente pianeggiante e procede in parte incassato fra gli alti muraglioni paraterra in pietra lavica, in parte lungo quattro tunnel e, per lunghi tratti, consente ampie vedute sulla sottostante spianata. Si potranno osservare, a distanza ravvicinata, le particolari rocce che compongono la Timpa, le “opere d’arte” della antica ingegneria ferroviaria e soprattutto la vegetazione che cresce lungo i suoi fianchi, costituita da essenze della macchia, non che da tratti di vegetazione boschiva, composta da Querce e Bagolaro. Da qui si potranno ammirare, sul lato mare, bei panorami verso la borgata di Santa Maria La Scala e, a monte, ville e imponenti opere di terrazzamento abbandonate. Avanzando per qualche centinaio di metri ci si inoltrerà fra alte pareti paraterra, imbattendosi nei resti di una galleria di scorrimento lavico. Questa grotta venne tranciata in due parti durante lo scavo della linea ferrata: nel troncone rivolto a marina si notano chiaramente le sezioni di due caratteristici rotoli laminari, mentre il troncone a monte è protetto da manufatti in muratura, in quanto esso fu modificato come luogo di riparo per gli addetti alla manutenzione ferroviaria. Procedendo ancora verso nord ci si parerà davanti l’ingresso di un primo tunnel ferroviario (in effetti il secondo del sistema, in quanto il primo è stato escluso dal nostro percorso), lungo circa 250 metri, che riceve luce dalle due estremità e da un’ampia finestra che si apre sul lato di levante. Andando ancora avanti vi sono altre due tunnel, il primo dei quali è rettilineo e breve (circa 150 metri), pertanto risulta decisamente illuminato dalla luce solare; nel suo interno troviamo varie nicchie laterali, ricavate per accogliere gli operai che lavoravano sulla linea ferrata al passaggio dei treni. Il secondo è lungo 468 metri, come si legge su una targa applicata nell’ingresso sud: per attraversarlo è necessario munirsi di una torcia. Sulla chiave dell’arco del suo ingresso nord si trova incisa la data “1912”: risale all’epoca in cui furono effettuati lavori di consolidamento a protezione del tunnel. Appena fuori dalla galleria lo sguardo si apre sul sottostante paesaggio, in cui emergono le borgate di Santa Tecla, Stazzo e Pozzillo. Sul lato a monte sarà invece possibile ammirare la boscaglia a Roverella tra cui spicca, proprio accanto un lavanara, un bellissimo esemplare di Lentisco. Da qui inizia un lungo tratto scoperto (circa 1200 m), in cui il lato a monte si rivolge verso aree collinari terrazzate e quello a mare sovrasta il già menzionato Pedi ‘i Timpa, con tutto il paesaggio multicolore delle colture e della costa ionica che si perde all’orizzonte. Al di là dell’insensato cancello si trova la parte settentrionale della Timpa di Santa Tecla, cioè la contrada Mortara, caratterizzata da estesi poderi coltivati a limone, straordinariamente abbarbicarti su precari terrazzamenti. Percorsi circa 200 metri si giunge ad un bivio: si imbocchi il ramo di destra, poiché quello di sinistra cambia denominazione (via D’Amico) e conduce presso la frazione di Scillichenti. Scendendo fra alte spallette dopo un po’ la strada si allarga e compie un’ampia curva ad U che sovrasta un ponte sulla nuova ferrovia. Da qui si gode di un ampio panorama sulla piana di Santa Tecla e sulle ubertose coltivazioni di agrumi che si abbarbicano sopra questa parte della Timpa. Andando ancora avanti sembra che la via Mortara finisca in un gruppo di caseggiati rurali, mentre in effetti continua con un percorso a T: il ramo verso est diventa una carrareccia difficilmente praticabile, mentre il ramo ad ovest si chiude a fondo cieco. In quest’ultimo è ubicato l’accesso ad un fondo privato chiuso da un cancello corredato da una caratteristica edicola votiva sovrastata da un cipresso. Affiancato a questo cancello ne troviamo un secondo che, se fosse aperto, introdurrebbe da nord alla sede del vecchio tracciato ferroviario. Il ramo verso est, una carrareccia dal fondo molto accidentato e scosceso, si ricongiunge nuovamente sulla strada asfaltata che conduce alla provinciale per Riposto, nei pressi del borgo di Santa Tecla. (12)
Grotta Falconiera. Lungo l’omoni a timpa la grotta Falconiera (vedi) è una grotta lavica visibile su entrambi i lati del percorso presumibilmente “tagliata” quando si è sviluppato il tracciato della ferrovia. In essa si riscontrano notevoli rotoli lavici.
Grotta Scannato. La grotta Scannatu (vedi) è formata da un’ampia galleria di scorrimento. L’ingresso, volto a nordovest, misura una decina di metri di larghezza e oltre sei metri di altezza ed è parzialmente occluso da manufatti in pietra e malta. Presso l’entrata della grotta si nota, a ridosso della parete sud, un calcinaio in pietra lavica. Il primo tratto della cavità è ampio circa quindici metri, alto circa sette metri, ha sezione ogivale e si estende per circa quarantacinque metri. Lungo la parete sud si nota un grosso rotolo di lava del diametro di un metro e mezzo. La grotta continua in direzione nordest, ad un livello di un metro più alto, con una galleria dalla volta bassa che presenta diverse ramificazioni. Quelle più ampie si aprono verso nord e vi si notano piccoli rotoli di lava addossati alle pareti e rare stalattiti da rifusione. Il pavimento si presenta notevolmente rimaneggiato nel primo tratto della cavità; nel secondo tratto è di lava a superficie unita, parzialmente coperta da uno strato di fango. Si notano alcune radici pendenti dalla volta. (13)
Santa Tecla. Posta a nord-est di Acireale ed adagiata ai piedi della Timpa falconiera, Santa Tecla (vedi) è oggi un centro balneare e residenziale. Le prime notizie storiche di Santa Tecla risalgono al XIII secolo e quindi la nascita del borgo ha preceduto quella tradizionale di Aquilia (oggi Acireale) datata nel XIV secolo approssimativamente. A partire dal XVI secolo a causa di alcune scorrerie di corsari turchi venne dotata di una garitta di guardia, che tuttavia non riuscì a difendere la frazione dal pirata Luccialì, che proprio lì sbarcò il 3 maggio 1582 al comando di sette galee e ben trecento pirati.
Torre del Greco. A partire dal XVI secolo, a causa di alcune scorrerie di corsari turchi, la frazione di Santa Tecla venne dotata di una garitta di guardia (vedi), che tuttavia non riuscì a difendere la frazione dal pirata Luccialì, che proprio lì sbarcò il 3 maggio 1582 al comando di sette galee e ben trecento pirati. Ai limiti del fiabesco la vita di questo pirata di origini calabresi. Uluch Alì nacque in Calabria, probabilmente col nome di Giovanni Dionigi Galeni, nel 1519. Stava per entrare in convento e divenire monaco, quando fu catturato dal corsaro algerino Khayr al-Dīn Barbarossa nel 1536 a Le Castella, presso Isola di Capo Rizzuto in Calabria. Fatto prigioniero e messo al remo, rinnegò la religione cristiana dopo alcuni anni, per poter uccidere un turco che lo aveva schiaffeggiato e non essere di conseguenza ucciso in base alla legge islamica[5]. Diventato musulmano, sposò la figlia di un altro calabrese convertito, Jaʿfar Pascià e iniziò la propria carriera di corsaro, con grande successo. Divenne dapprima comandante della flotta di Alessandria, poi pascià d’Algeri, e infine bey (governatore) di Tripoli. Da corsaro imperversò in tutto il Mar Mediterraneo. Opera sua furono le catture nei pressi di Favignana della galera di Pietro Mendoza (1555 ca.), a Marettimo quella di Vincenzo Cicala e Luigi Osorio (1561). Il suo nome è legato a numerose incursioni sulle coste italiane, soprattutto quelle del Regno di Napoli, allora dominio spagnolo. Secondo alcune voci dell’epoca, tramò anche con vari cospiratori calabresi per staccare la Calabria dai regni spagnoli e unirla ai domini turchi. Partecipò alla battaglia di Gerba nel 1560 e successivamente cercò di catturare il duca Emanuele Filiberto di Savoia presso Nizza. Nel 1564 partecipò ai ripetuti assalti e ai saccheggi del paese di Civezza, nell’attuale provincia di Imperia. L’eroica resistenza della popolazione del piccolo paesino passò alla storia. Subentrò a Dragut a capo della flotta ottomana, quando questi morì durante l’assedio di Malta del 1565. Fu quindi autore di rilevanti imprese belliche, fra le quali l’assalto e il successivo assedio nell’agosto 1571 della città dalmata di Curzola. Considerato il miglior ammiraglio della flotta ottomana, nell’ottobre del 1571 combatté a Lepanto contro Gianandrea Doria. Riuscì ad insidiare Don Giovanni d’Austria ed a riportare in salvo una trentina di navi turche recando ad Istanbul, come trofeo, lo stendardo dei Cavalieri di Malta dopo una precipitosa fuga durante l’infuriare della battaglia. Dopo questa battaglia ottenne dal Sultano ottomano Selim II il titolo di ammiraglio della flotta turca e l’appellativo di Kılıç Alì (Alì la Spada). Forte della nuova carica ricostruì in un anno la flotta distrutta a Lepanto e nel 1572 riuscì a sfidare ancora le flotte cristiane, anche se con scarso successo. Nel 1574 riconquistò all’impero ottomano Tunisi, che era stata espugnata l’anno prima dalla flotta cristiana. Morì nel luglio del 1587 nel suo palazzo sulla collina di Top-Hana vicino Istanbul e lasciò ai suoi numerosi schiavi e servitori case e beni di proprietà, concentrati in un villaggio da lui fondato e chiamato “Nuova Calabria”. Secondo alcuni resoconti, in punto di morte sarebbe tornato alla fede cristiana, ma gli storici turchi negano con decisione questa eventualità, visto che già in vita gli erano stati offerti feudi e ricchezze in terre cristiane che egli aveva sempre rifiutato preferendo la libertà di costumi di cui godevano a quel tempo i cristiani convertiti all’Islam. Altra leggenda che circola sul suo nome racconta di un viaggio clandestino sulla costa calabrese al solo scopo di riabbracciare la madre che, stando alle cronache coeve, lo avrebbe invece maledetto proprio per la sua abiura. Ricerche recenti, però, ascrivono questa leggenda alla propaganda spagnola ed ecclesiastica.
Pagine Etnanatura:
- Capomulini
- Tempio romano di Capomulini
- Torri Alessandrano e sant’Anna
- Gazzena
- Villa Calanna
- Acque grandi
- Pietra Monaca
- Chiazzette
- Fortezza del Tocco
- Santa Maria la Scala
- Miuccio
- Grotta delle palombe
- Grotta santa Maria della Meve
- Timpa Falconiera
- Grotta Falconiera
- Grotta Scannato
- Santa Tecla
- Torre del greco
Foto Etnanatura e Michele Torrisi
Sitografia:
Dove non specificato le notizie sono dovute a Wikipedia
1) INGV Catania. http://www.ct.ingv.it/it/component/content/article/29-uf-vulcanologia-e-geochimica/etna/161-evoluzione-geologica-del-monte-etna.html?showall=&start=2
2) http://digilander.libero.it/latimpa/it/fauna/ fauna.html
3) http://digilander.libero.it/latimpa/it/flora/flora.html
4) http://riservalatimpa.blogspot.it/2011/06/sentiero-della-gazzena.html
5) http://www.startnews.it/notizie/START_WRITE_NEWS_10.ASP?KEY=4553
6) http://riservalatimpa.blogspot.it/2011/06/sentiero-delle-acquegrandi.html
7) http://riservalatimpa.blogspot.it/2011/06/santa-caterina-e-lacqua-del-ferro.html
8) http://riservalatimpa.blogspot.it/2011/06/pietra-monaca.html
9) http://riservalatimpa.blogspot.it/2011/06/le-chiazzette.html
10) http://www.ipaesaggi.eu/itinerari/88-capomulini.html
11) Testo tratto dall’opuscolo “Angeli e Campane”
12) http://riservalatimpa.blogspot.it/2011/06/la-timpa-di-santa-tecla.html
13) http://www.mungibeddu.it/mungibeddu/schede/060.html
Torre del Greco
 A partire dal XVI secolo, a causa di alcune scorrerie di corsari turchi, la frazione di Santa Tecla venne dotata di una garitta di guardia, che tuttavia non riuscì a difendere la frazione dal pirata Luccialì, che proprio lì sbarcò il 3 maggio 1582 al comando di sette galee e ben trecento pirati. Ai limiti del fiabesco la vita di questo pirata di origini calabresi. Uluch Alì nacque in Calabria, probabilmente col nome di Giovanni Dionigi Galeni, nel 1519. Stava per entrare in convento e divenire monaco, quando fu catturato dal corsaro algerino Khayr al-Dīn Barbarossa nel 1536 a Le Castella, presso Isola di Capo Rizzuto in Calabria. Fatto prigioniero e messo al remo, rinnegò la religione cristiana dopo alcuni anni, per poter uccidere un turco che lo aveva schiaffeggiato e non essere di conseguenza ucciso in base alla legge islamica[5]. Diventato musulmano, sposò la figlia di un altro calabrese convertito, Jaʿfar Pascià e iniziò la propria carriera di corsaro, con grande successo. Divenne dapprima comandante della flotta di Alessandria, poi pascià d’Algeri, e infine bey (governatore) di Tripoli. Da corsaro imperversò in tutto il Mar Mediterraneo. Opera sua furono le catture nei pressi di Favignana della galera di Pietro Mendoza (1555 ca.), a Marettimo quella di Vincenzo Cicala e Luigi Osorio (1561). Il suo nome è legato a numerose incursioni sulle coste italiane, soprattutto quelle del Regno di Napoli, allora dominio spagnolo. Secondo alcune voci dell’epoca, tramò anche con vari cospiratori calabresi per staccare la Calabria dai regni spagnoli e unirla ai domini turchi. Partecipò alla battaglia di Gerba nel 1560 e successivamente cercò di catturare il duca Emanuele Filiberto di Savoia presso Nizza. Nel 1564 partecipò ai ripetuti assalti e ai saccheggi del paese di Civezza, nell’attuale provincia di Imperia. L’eroica resistenza della popolazione del piccolo paesino passò alla storia. Subentrò a Dragut a capo della flotta ottomana, quando questi morì durante l’assedio di Malta del 1565. Fu quindi autore di rilevanti imprese belliche, fra le quali l’assalto e il successivo assedio nell’agosto 1571 della città dalmata di Curzola. Considerato il miglior ammiraglio della flotta ottomana, nell’ottobre del 1571 combatté a Lepanto contro Gianandrea Doria. Riuscì ad insidiare Don Giovanni d’Austria ed a riportare in salvo una trentina di navi turche recando ad Istanbul, come trofeo, lo stendardo dei Cavalieri di Malta dopo una precipitosa fuga durante l’infuriare della battaglia. Dopo questa battaglia ottenne dal Sultano ottomano Selim II il titolo di ammiraglio della flotta turca e l’appellativo di Kılıç Alì (Alì la Spada). Forte della nuova carica ricostruì in un anno la flotta distrutta a Lepanto e nel 1572 riuscì a sfidare ancora le flotte cristiane, anche se con scarso successo. Nel 1574 riconquistò all’impero ottomano Tunisi, che era stata espugnata l’anno prima dalla flotta cristiana. Morì nel luglio del 1587 nel suo palazzo sulla collina di Top-Hana vicino Istanbul e lasciò ai suoi numerosi schiavi e servitori case e beni di proprietà, concentrati in un villaggio da lui fondato e chiamato “Nuova Calabria”. Secondo alcuni resoconti, in punto di morte sarebbe tornato alla fede cristiana, ma gli storici turchi negano con decisione questa eventualità, visto che già in vita gli erano stati offerti feudi e ricchezze in terre cristiane che egli aveva sempre rifiutato preferendo la libertà di costumi di cui godevano a quel tempo i cristiani convertiti all’Islam. Altra leggenda che circola sul suo nome racconta di un viaggio clandestino sulla costa calabrese al solo scopo di riabbracciare la madre che, stando alle cronache coeve, lo avrebbe invece maledetto proprio per la sua abiura. Ricerche recenti, però, ascrivono questa leggenda alla propaganda spagnola ed ecclesiastica.
A partire dal XVI secolo, a causa di alcune scorrerie di corsari turchi, la frazione di Santa Tecla venne dotata di una garitta di guardia, che tuttavia non riuscì a difendere la frazione dal pirata Luccialì, che proprio lì sbarcò il 3 maggio 1582 al comando di sette galee e ben trecento pirati. Ai limiti del fiabesco la vita di questo pirata di origini calabresi. Uluch Alì nacque in Calabria, probabilmente col nome di Giovanni Dionigi Galeni, nel 1519. Stava per entrare in convento e divenire monaco, quando fu catturato dal corsaro algerino Khayr al-Dīn Barbarossa nel 1536 a Le Castella, presso Isola di Capo Rizzuto in Calabria. Fatto prigioniero e messo al remo, rinnegò la religione cristiana dopo alcuni anni, per poter uccidere un turco che lo aveva schiaffeggiato e non essere di conseguenza ucciso in base alla legge islamica[5]. Diventato musulmano, sposò la figlia di un altro calabrese convertito, Jaʿfar Pascià e iniziò la propria carriera di corsaro, con grande successo. Divenne dapprima comandante della flotta di Alessandria, poi pascià d’Algeri, e infine bey (governatore) di Tripoli. Da corsaro imperversò in tutto il Mar Mediterraneo. Opera sua furono le catture nei pressi di Favignana della galera di Pietro Mendoza (1555 ca.), a Marettimo quella di Vincenzo Cicala e Luigi Osorio (1561). Il suo nome è legato a numerose incursioni sulle coste italiane, soprattutto quelle del Regno di Napoli, allora dominio spagnolo. Secondo alcune voci dell’epoca, tramò anche con vari cospiratori calabresi per staccare la Calabria dai regni spagnoli e unirla ai domini turchi. Partecipò alla battaglia di Gerba nel 1560 e successivamente cercò di catturare il duca Emanuele Filiberto di Savoia presso Nizza. Nel 1564 partecipò ai ripetuti assalti e ai saccheggi del paese di Civezza, nell’attuale provincia di Imperia. L’eroica resistenza della popolazione del piccolo paesino passò alla storia. Subentrò a Dragut a capo della flotta ottomana, quando questi morì durante l’assedio di Malta del 1565. Fu quindi autore di rilevanti imprese belliche, fra le quali l’assalto e il successivo assedio nell’agosto 1571 della città dalmata di Curzola. Considerato il miglior ammiraglio della flotta ottomana, nell’ottobre del 1571 combatté a Lepanto contro Gianandrea Doria. Riuscì ad insidiare Don Giovanni d’Austria ed a riportare in salvo una trentina di navi turche recando ad Istanbul, come trofeo, lo stendardo dei Cavalieri di Malta dopo una precipitosa fuga durante l’infuriare della battaglia. Dopo questa battaglia ottenne dal Sultano ottomano Selim II il titolo di ammiraglio della flotta turca e l’appellativo di Kılıç Alì (Alì la Spada). Forte della nuova carica ricostruì in un anno la flotta distrutta a Lepanto e nel 1572 riuscì a sfidare ancora le flotte cristiane, anche se con scarso successo. Nel 1574 riconquistò all’impero ottomano Tunisi, che era stata espugnata l’anno prima dalla flotta cristiana. Morì nel luglio del 1587 nel suo palazzo sulla collina di Top-Hana vicino Istanbul e lasciò ai suoi numerosi schiavi e servitori case e beni di proprietà, concentrati in un villaggio da lui fondato e chiamato “Nuova Calabria”. Secondo alcuni resoconti, in punto di morte sarebbe tornato alla fede cristiana, ma gli storici turchi negano con decisione questa eventualità, visto che già in vita gli erano stati offerti feudi e ricchezze in terre cristiane che egli aveva sempre rifiutato preferendo la libertà di costumi di cui godevano a quel tempo i cristiani convertiti all’Islam. Altra leggenda che circola sul suo nome racconta di un viaggio clandestino sulla costa calabrese al solo scopo di riabbracciare la madre che, stando alle cronache coeve, lo avrebbe invece maledetto proprio per la sua abiura. Ricerche recenti, però, ascrivono questa leggenda alla propaganda spagnola ed ecclesiastica.
Da Wikipedia
Pagina Etnanatura: Torre del Greco.
Torri sant’Anna e Alessandrano
 Sia la Torre Alessandrano che la quadrangolare Torre di Sant’Anna nel borgo di Capo Mulini (1585), insieme con la Garitta di S. Tecla (vedi) e la Fortezza del Tocco (vedi), protessero la Timpa di Santa Maria La Scala (1592-1616) secondo il piano di fortificazione federiciano di epoca sveva. La Torre Sant’Anna, fu iniziata nel 1582 in corrispondenza del Capo Mulini e finita in circa un ventennio. Vi alloggiava un corpo di guardia con il compito di allertare all’avvicinarsi di navi corsare. Nel 1868 la torre di Sant’Anna venne convertita in faro. Oggi si trova in una proprietà privata.
Sia la Torre Alessandrano che la quadrangolare Torre di Sant’Anna nel borgo di Capo Mulini (1585), insieme con la Garitta di S. Tecla (vedi) e la Fortezza del Tocco (vedi), protessero la Timpa di Santa Maria La Scala (1592-1616) secondo il piano di fortificazione federiciano di epoca sveva. La Torre Sant’Anna, fu iniziata nel 1582 in corrispondenza del Capo Mulini e finita in circa un ventennio. Vi alloggiava un corpo di guardia con il compito di allertare all’avvicinarsi di navi corsare. Nel 1868 la torre di Sant’Anna venne convertita in faro. Oggi si trova in una proprietà privata.
Pagina Etnanatura: Alessandrano e sant’Anna.
Catania sconosciuta
 Con l’arrivo dell’inverno potrebbe essere interessante scoprire con poco sforzo le bellezze nascoste di Catania. Tutti conoscono la via Etnea e molti apprezzano per la sua bellezza via Crociferi ma quanti sono in grado di individuare il percorso sotterraneo del fiume Amenano, ritrovare le vestigia romane della città o i resti delle mura che l’hanno difesa dalle invasioni? Sono i piccoli tesori nascosti, spesso sconosciuti se non trascurati, che restituiscono la bellezza e il fascino misterioso di una città unica. Ed è per questo che vi proponiamo tre itinerari nella storia della città:
Con l’arrivo dell’inverno potrebbe essere interessante scoprire con poco sforzo le bellezze nascoste di Catania. Tutti conoscono la via Etnea e molti apprezzano per la sua bellezza via Crociferi ma quanti sono in grado di individuare il percorso sotterraneo del fiume Amenano, ritrovare le vestigia romane della città o i resti delle mura che l’hanno difesa dalle invasioni? Sono i piccoli tesori nascosti, spesso sconosciuti se non trascurati, che restituiscono la bellezza e il fascino misterioso di una città unica. Ed è per questo che vi proponiamo tre itinerari nella storia della città:
I mulini di Aci
 I mulini ad acqua di Aci Catena sono delle costruzioni ubicate ad Aci Catena in Sicilia, nei pressi della frazione di Aci San Filippo, nella vallata greco-romana di Reitana e costituiscono l’ itinerario storico dove si svolgeva la Fiera Franca di S. Venera, dal 19 luglio al 2 agosto di ogni anno, dal 1422 al 1615, molto famosa in quei tempi, sancita come “Franca” (cioè esente da dazio) con decreto del Re Alfonso I il Magnanimo e successivamente confermato nel 1531, da Carlo V di Spagna. La costruzione dei mulini fu dovuta principalmente alla grande quantità di acqua disponibile sul territorio. A piano Reitana si trova un primo gruppo di sorgenti (sorgenti Cuba): vi sbocca l’acquedotto Casalotto. Quando all’acquedotto si verificava un sovrappiù di acqua si apriva un sistema di chiusura che faceva defluire l’acqua all’inizio della saia mastra, un grosso canale in muratura, dove veniva convogliata l’acqua delle sorgenti. L’acqua di Casalotto proveniva da sorgenti a monte,- la zona di Aci Catena, Aci S. Antonio, Valverde, Aci Bonaccorsi, San Giovanni La Punta – veniva usata per l’irrigazione degli agrumeti della costa ionica e per usi potabili nell’hinterland della provincia di Catania. La piazza Reitana è famosa per la lavorazione dei lupini, grazie alla presenza dell’acqua delle sorgenti. Piano Reitana [modifica] Tratto della saia mastra Il grande avvallamento di piano Reitana è ritenuto l’alveo di uno dei rami del fiume Aci: la presenza di argille nel terreno permette l’affioramento delle acque. La zona Reitana, risparmiata dalle eruzioni etnee, ha conservato un complesso basale formato da argille pleistoceniche: ciò ha consentito la possibilità di ritrovamenti archeologici, di cui la zona era ricchissima (monete, vasi, lacrimatoi, tombe). Costeggiando la saia mastra (detta anche fiumara) si giunge ai ruderi del primo mulino denominato Spezzacoddu, per via di un uomo violento che vi faceva il guardiano. Il mulino è ubicato sulla sinistra, prima di prendere la salita della strada per Vampolieri. I mulini erano costituiti da una botte cilindrica – dove cadeva a pressione l’acqua della saia che metteva in funzione il meccanismo della macina – e da un arco chiamato caraffo. I ruderi del secondo mulino, una volta abitato dalla signora Npacchiapa, un tempo ospitavano una scuola di campagna: vi era anche la stalla dei muli. Piano Pescheria [modifica] Al piano Pescheria sono ubicati il secondo gruppo di sorgenti, alcune attive altre spente: Funtanedda, con una cupola abbandonata, è una sorgente spenta, Pescheria è invece una sorgente attiva. Nella campagna vicina, chiamata Pignatelli e Isola , si hanno altre due sorgenti Spanneddi e Paratore. In questa campagna nel 1817 fu scoperta una villa romana con il Mosaico del Pegaso. Nel pianoro Pescheria inizia un torrentello (vadduneddu) che costeggia la saia mastra. Il terzo mulino da zia Nedda, sorella di don Neddu oggi chiamato Scardaci, è l’unico ristrutturato che può ancora dare l’idea del vecchio mulino. Proprio questo punto, costituisce un’oasi naturale, dove si possono ammirare le cascate dell’acqua, che fino ad una trentina di anni fa, muovevano la ruota del mulino, uno degli ultimi funzionanti. All’interno di questo mulino ci sono tre cascate d’acqua che ingrossano la saia, che attraversa al di sotto dello stesso mulino, proseguendo tra i papiri, per raggiungere gli altri mulini. Lì vicino, in via Paratore, si trova il fondaco: era il luogo di ristoro e di riposo durante la notte per i carrettieri e i cavalcaturi che venivano in questi mulini per la macina del grano. Vicino al fondaco c’è un lavatoio. Nelle acque di questo tratto di fiumara si possono incontrare granchi di acqua dolce, anguille e rane. Attraversando la ferrovia, sopra un moderno ponte pedonale, si arriva al quarto mulino U mulinu a via, ex mulino Don Neddu, dalla caratteristica costruzione rossa. Si giunge quindi alla contrada baracche, frazione di Acireale, con la chiesetta di S. Andrea. Qui è presente il quinto mulino Don Pippino”, funzionante fino agli anni sessanta e così via il sesto, settimo, ottavo mulino, oggi abitazioni (lungo la via Montevago). Attraversando la statale – nel luogo dove esisteva il nono mulino, oggi luogo residenziale – in zona chiamata A chianata di Vigo, si incontra l’ultima sorgente, la mutaddisa. Scendendo per la strada asfaltata si giunge a Capomulini (frazione di Acireale) che prese appunto il nome dalla presenza dei mulini. Qui troviamo l’ultimo mulino, oggi abitazione. Sugli scogli a mare nello stesso sito sboccano la saia mastra (fiumara regitana), il torrentello (vadduneddu) e il torrente Lavinaio. L’ambiente dei mulini [modifica] Nel territorio di Aci S. Filippo, S. Nicolò, Reitana, Pianura del Torrente Platani e valli dei Mulini, cioè la porzione sud del territorio delle Aci, la componente fisica dell’ambiente costituì un’attrazione importante per i primi processi di antropizzazione. L’area possedeva infatti tutte quelle condizioni naturali che consentivano una facile sopravvivenza per uomini non dotati di tecnologia e permettevano benessere e veloce progresso. Tali condizioni erano e sono sostanzialmente ancora rappresentate da: Disponibilità idriche in abbondanza in qualsiasi stagione: l’area rappresenta una zona di convergenza di importanti deflussi idrici superficiali e sotterranei di una buona porzione del versante sub-orientale dell’Etna. Se anche oggi, con i massicci prelievi idrici a monte e con minori precipitazioni rispetto a qualche millennio fa, l’area è un fiorire di pozzi, sorgenti (anche termali) e canalizzazioni, un tempo costituì un proscenio di tutte le possibili rappresentazioni che l’acqua nel continente poteva esprimere. I depositi alluvionali, le paleoforme fluviali, gli effetti visibili sulla roccia, rappresentati da molature e fossette di erosione idrica, testimoniano di un passato in cui le acque in tutte le forme e attività costituivano il protagonista ambientale del territorio. Suolo naturalmente fertile di origine alluvionale, particolarmente predisposto a trasformarsi in suolo agrario. Nella pianura alluvionale del Torrente Platani e in tutto il circondario di Reitana, sono presenti i terreni più fertili dell’Etna. Disponibilità di terreni argillosi: le complesse vicende geologiche hanno generato nell’area l’unico vero affioramento argilloso all’interno del perimetro vulcanico etneo. Sicuramente l’unico rilevante per impiantare cave di argilla. La collina dell’Olivo S. Mauro-Torre Reitana e dei Mulini, con la presenza di argille pleistoceniche costituivano, fino a qualche decennio fa, l’area del prelievo dell’argilla per una fiorente industria dei prodotti ceramici che risale a diversi millenni fa. Microclima favorevole: la protezione del gradino morfologico della Timpa di Acicatena-Aci. S. Filippo-S. Nicolò a ovest e a nord e la sua felice esposizione a oriente e a sud, conferisce all’area un microclima caratterizzato da una maggiore mitezza rispetto al territorio circostante. Lo testimoniano, oltre che i dati meteorologici, la grande produttività agricola dell’area, caratterizzata dall’areale limonicolo e orticolo tra i più produttivi dell’intera provincia etnea. Approdo costiero: Capo Mulini è uno dei pochi approdi naturali relativamente protetti di cui dispone la costa etnea.
I mulini ad acqua di Aci Catena sono delle costruzioni ubicate ad Aci Catena in Sicilia, nei pressi della frazione di Aci San Filippo, nella vallata greco-romana di Reitana e costituiscono l’ itinerario storico dove si svolgeva la Fiera Franca di S. Venera, dal 19 luglio al 2 agosto di ogni anno, dal 1422 al 1615, molto famosa in quei tempi, sancita come “Franca” (cioè esente da dazio) con decreto del Re Alfonso I il Magnanimo e successivamente confermato nel 1531, da Carlo V di Spagna. La costruzione dei mulini fu dovuta principalmente alla grande quantità di acqua disponibile sul territorio. A piano Reitana si trova un primo gruppo di sorgenti (sorgenti Cuba): vi sbocca l’acquedotto Casalotto. Quando all’acquedotto si verificava un sovrappiù di acqua si apriva un sistema di chiusura che faceva defluire l’acqua all’inizio della saia mastra, un grosso canale in muratura, dove veniva convogliata l’acqua delle sorgenti. L’acqua di Casalotto proveniva da sorgenti a monte,- la zona di Aci Catena, Aci S. Antonio, Valverde, Aci Bonaccorsi, San Giovanni La Punta – veniva usata per l’irrigazione degli agrumeti della costa ionica e per usi potabili nell’hinterland della provincia di Catania. La piazza Reitana è famosa per la lavorazione dei lupini, grazie alla presenza dell’acqua delle sorgenti. Piano Reitana [modifica] Tratto della saia mastra Il grande avvallamento di piano Reitana è ritenuto l’alveo di uno dei rami del fiume Aci: la presenza di argille nel terreno permette l’affioramento delle acque. La zona Reitana, risparmiata dalle eruzioni etnee, ha conservato un complesso basale formato da argille pleistoceniche: ciò ha consentito la possibilità di ritrovamenti archeologici, di cui la zona era ricchissima (monete, vasi, lacrimatoi, tombe). Costeggiando la saia mastra (detta anche fiumara) si giunge ai ruderi del primo mulino denominato Spezzacoddu, per via di un uomo violento che vi faceva il guardiano. Il mulino è ubicato sulla sinistra, prima di prendere la salita della strada per Vampolieri. I mulini erano costituiti da una botte cilindrica – dove cadeva a pressione l’acqua della saia che metteva in funzione il meccanismo della macina – e da un arco chiamato caraffo. I ruderi del secondo mulino, una volta abitato dalla signora Npacchiapa, un tempo ospitavano una scuola di campagna: vi era anche la stalla dei muli. Piano Pescheria [modifica] Al piano Pescheria sono ubicati il secondo gruppo di sorgenti, alcune attive altre spente: Funtanedda, con una cupola abbandonata, è una sorgente spenta, Pescheria è invece una sorgente attiva. Nella campagna vicina, chiamata Pignatelli e Isola , si hanno altre due sorgenti Spanneddi e Paratore. In questa campagna nel 1817 fu scoperta una villa romana con il Mosaico del Pegaso. Nel pianoro Pescheria inizia un torrentello (vadduneddu) che costeggia la saia mastra. Il terzo mulino da zia Nedda, sorella di don Neddu oggi chiamato Scardaci, è l’unico ristrutturato che può ancora dare l’idea del vecchio mulino. Proprio questo punto, costituisce un’oasi naturale, dove si possono ammirare le cascate dell’acqua, che fino ad una trentina di anni fa, muovevano la ruota del mulino, uno degli ultimi funzionanti. All’interno di questo mulino ci sono tre cascate d’acqua che ingrossano la saia, che attraversa al di sotto dello stesso mulino, proseguendo tra i papiri, per raggiungere gli altri mulini. Lì vicino, in via Paratore, si trova il fondaco: era il luogo di ristoro e di riposo durante la notte per i carrettieri e i cavalcaturi che venivano in questi mulini per la macina del grano. Vicino al fondaco c’è un lavatoio. Nelle acque di questo tratto di fiumara si possono incontrare granchi di acqua dolce, anguille e rane. Attraversando la ferrovia, sopra un moderno ponte pedonale, si arriva al quarto mulino U mulinu a via, ex mulino Don Neddu, dalla caratteristica costruzione rossa. Si giunge quindi alla contrada baracche, frazione di Acireale, con la chiesetta di S. Andrea. Qui è presente il quinto mulino Don Pippino”, funzionante fino agli anni sessanta e così via il sesto, settimo, ottavo mulino, oggi abitazioni (lungo la via Montevago). Attraversando la statale – nel luogo dove esisteva il nono mulino, oggi luogo residenziale – in zona chiamata A chianata di Vigo, si incontra l’ultima sorgente, la mutaddisa. Scendendo per la strada asfaltata si giunge a Capomulini (frazione di Acireale) che prese appunto il nome dalla presenza dei mulini. Qui troviamo l’ultimo mulino, oggi abitazione. Sugli scogli a mare nello stesso sito sboccano la saia mastra (fiumara regitana), il torrentello (vadduneddu) e il torrente Lavinaio. L’ambiente dei mulini [modifica] Nel territorio di Aci S. Filippo, S. Nicolò, Reitana, Pianura del Torrente Platani e valli dei Mulini, cioè la porzione sud del territorio delle Aci, la componente fisica dell’ambiente costituì un’attrazione importante per i primi processi di antropizzazione. L’area possedeva infatti tutte quelle condizioni naturali che consentivano una facile sopravvivenza per uomini non dotati di tecnologia e permettevano benessere e veloce progresso. Tali condizioni erano e sono sostanzialmente ancora rappresentate da: Disponibilità idriche in abbondanza in qualsiasi stagione: l’area rappresenta una zona di convergenza di importanti deflussi idrici superficiali e sotterranei di una buona porzione del versante sub-orientale dell’Etna. Se anche oggi, con i massicci prelievi idrici a monte e con minori precipitazioni rispetto a qualche millennio fa, l’area è un fiorire di pozzi, sorgenti (anche termali) e canalizzazioni, un tempo costituì un proscenio di tutte le possibili rappresentazioni che l’acqua nel continente poteva esprimere. I depositi alluvionali, le paleoforme fluviali, gli effetti visibili sulla roccia, rappresentati da molature e fossette di erosione idrica, testimoniano di un passato in cui le acque in tutte le forme e attività costituivano il protagonista ambientale del territorio. Suolo naturalmente fertile di origine alluvionale, particolarmente predisposto a trasformarsi in suolo agrario. Nella pianura alluvionale del Torrente Platani e in tutto il circondario di Reitana, sono presenti i terreni più fertili dell’Etna. Disponibilità di terreni argillosi: le complesse vicende geologiche hanno generato nell’area l’unico vero affioramento argilloso all’interno del perimetro vulcanico etneo. Sicuramente l’unico rilevante per impiantare cave di argilla. La collina dell’Olivo S. Mauro-Torre Reitana e dei Mulini, con la presenza di argille pleistoceniche costituivano, fino a qualche decennio fa, l’area del prelievo dell’argilla per una fiorente industria dei prodotti ceramici che risale a diversi millenni fa. Microclima favorevole: la protezione del gradino morfologico della Timpa di Acicatena-Aci. S. Filippo-S. Nicolò a ovest e a nord e la sua felice esposizione a oriente e a sud, conferisce all’area un microclima caratterizzato da una maggiore mitezza rispetto al territorio circostante. Lo testimoniano, oltre che i dati meteorologici, la grande produttività agricola dell’area, caratterizzata dall’areale limonicolo e orticolo tra i più produttivi dell’intera provincia etnea. Approdo costiero: Capo Mulini è uno dei pochi approdi naturali relativamente protetti di cui dispone la costa etnea.
Foto di Etnanatura e Mario Antonio Pulvirenti
Pagina Etnanatura: I mulini di Aci.
Catania fortificata
Le mura di Carlo V
di Laura Gullotta
Il XVI secolo fu, per la Sicilia, un periodo caratterizzato da un peggioramento della situazione politica ed economica. Nel 1516 moriva re Ferdinando il Cattolico, al quale succedette il nipote Carlo, figlio dell’arciduca d’Austria Filippo il Bello e della regina di Castiglia Giovanna la Pazza, e dunque erede delle corone di Spagna e di quella imperiale del Sacro romano impero. Ereditò i domini materni con il nome di Carlo I, e cioè: l’Aragona, la Castiglia, i possedimenti italiani (Napoli, Sicilia e Sardegna) e i territori americani. Con la morte di Massimiliano I, nel 1519, Carlo ereditò anche i domini di casa d’Austria. Venne eletto imperatore nel 1519, con il nome di Carlo V. Sotto Carlo V il viceregno di Sicilia cominciò a perdere di importanza, tanto che l’imperatore visitò la Sicilia una sola volta, nel 1535, anno in cui venne incoronato re di Sicilia nel duomo di Palermo. Ripartì poi per il regno di Napoli, lasciando Ferdinando Gonzaga come viceré di Sicilia. La situazione lungo le coste italiane, nel frattempo, si stava facendo sempre più difficile a causa delle continue incursioni turche, e Catania stessa fu teatro di scontri tra i cittadini e soldati ottomani, che furono però costretti alla fuga. Il nuovo viceré Ferdinando de Vega ordinò allora il rafforzamento del Castello Ursino e la costruzione di garitte in pietra lavica lungo tutta la costa, dalle quali le vedette avrebbero potuto segnalare l’avvicinarsi delle navi nemiche e preparare così la città alla difesa.
 Su ordine dell’imperatore Carlo V, il viceré Giovanni de Vega progettò la costruzione di una nuova cinta muraria che sostituisse le ormai deteriorate mura medievali; la città presentava infatti già in epoca medievale un ampio sistema difensivo: le mura erano dritte e divise da torri quadrate. Tale sistema divenne tuttavia obsoleto e venne sostituito da una più moderna e consona cinta muraria difensiva: le nuove mura vennero erette per garantire una maggiore protezione dalle incursioni turche e per adeguarsi alle nuove tecniche militari; la nuova costruzione risultò essere più spessa rispetto alla precedente e caratterizzata da scarpate che permettessero una maggiore resistenza alle palle di cannone. I lavori cominciarono nel 1553, dopo che i rappresentanti spagnoli, riunitosi a Catania l’anno precedente, decisero di assegnare un contributo in cinque anni di mille scudi per il restauro dei muri e la creazione di bastioni e porte di accesso. Il percorso delle nuove mura così si articolava: partendo dalla Porta di Carlo V o dei Canali (così detta poiché si affacciava sui trentasei canali della marina attraverso i quali l’Amenano si riversava in mare), l’unica porta di cui rimanga traccia, ubicata nella zona in cui si svolge oggi il mercato della pescheria, svoltando a sinistra si incontrava la muraglia di S.Agata, che si estendeva fino alla Porta del Porticello o Saracena (detta anche De Vega, in onore del viceré), tra piazza S. Placido e via Dusmet; si giungeva poi al Bastione Piccolo, che si trovava alla marina, detto anche di Don Perrucchio, in onore di Perrucchio Gioeni, che aveva partecipato ad una spedizione in Tunisia con Carlo V. Proseguendo si raggiungeva il Bastione Grande o del Salvatore, tra via Dusmet e via Porta di Ferro, congiungendosi alla Porta di Ferro, in fondo alla via omonima, e al Bastione di S. Giuliano, così chiamato per via dell’omonimo monastero posto accanto, in piazza Cutelli.Continuando il percorso si arrivava alla Porta di S. Orsola, in piazza Scammacca, e al Bastione di S. Michele, il cui nome si riferiva ad una cappella vicina dedicata all’Arcangelo, nell’attuale Piazza Spirito Santo. La Porta di Aci (da cui partiva una strada che arrivava al Castello di Aci), o Stesicorea (per via della sua vicinanza alla tomba del poeta Stesicoro), si trovava nei pressi della chiesa dedicata a S. Carlo Borromeo; proseguendo si giungeva al Bastione del Santo Carcere, nella salita dei Cappuccini, vicino alla chiesa di S. Agata la Vetere, che andava ad unirsi alla Porta del Re, innalzata da Federico III d’Aragona. Andando avanti si giungeva al Bastione degli Infetti o del Vescovo, in cui era ubicata una torre di epoca medievale donata al vescovo Antonio de Vulpone, tra la via Plebiscito e la via Lago di Nicito; poco lontano si trovava il Bastione del Tindaro o del Tonnaro o, ancora, dell’Arcora, poiché nelle vicinanze vi erano le arcate dell’acquedotto di epoca romana che portava l’acqua da Valcorrente in città. Dopodiché il muro proseguiva verso il Bastione di S. Giovanni, tra via Garibaldi e via Plebiscito, congiungendosi al Bastione S. Euplio, tra piazza Cristoforo e piazza S. Antonio, e si univa alla Porta della Decima, così chiamata per via degli uffici delle tasse sulla decima che si trovavano lì vicino. Il muro scendeva poi ai lati del Castello Ursino, formando il Bastione di S. Giorgio e, voltando nell’attuale Via Scuto e via Zurria, arrivava al Bastione S. Croce, che difendeva la città dalla parte del mare. Il muro si congiungeva poi alla Porta dei Canali, completando il percorso. A causa della colata lavica del 1669 e del terremoto del 1693, le mura furono quasi interamente distrutte: parte delle mura furono utilizzate dalle famiglie aristocratiche più importanti della città per ricostruire i propri palazzi. La via del Plebiscito, inoltre, venne creata dopo il terremoto, seguendo il tracciato delle vecchie mura.
Su ordine dell’imperatore Carlo V, il viceré Giovanni de Vega progettò la costruzione di una nuova cinta muraria che sostituisse le ormai deteriorate mura medievali; la città presentava infatti già in epoca medievale un ampio sistema difensivo: le mura erano dritte e divise da torri quadrate. Tale sistema divenne tuttavia obsoleto e venne sostituito da una più moderna e consona cinta muraria difensiva: le nuove mura vennero erette per garantire una maggiore protezione dalle incursioni turche e per adeguarsi alle nuove tecniche militari; la nuova costruzione risultò essere più spessa rispetto alla precedente e caratterizzata da scarpate che permettessero una maggiore resistenza alle palle di cannone. I lavori cominciarono nel 1553, dopo che i rappresentanti spagnoli, riunitosi a Catania l’anno precedente, decisero di assegnare un contributo in cinque anni di mille scudi per il restauro dei muri e la creazione di bastioni e porte di accesso. Il percorso delle nuove mura così si articolava: partendo dalla Porta di Carlo V o dei Canali (così detta poiché si affacciava sui trentasei canali della marina attraverso i quali l’Amenano si riversava in mare), l’unica porta di cui rimanga traccia, ubicata nella zona in cui si svolge oggi il mercato della pescheria, svoltando a sinistra si incontrava la muraglia di S.Agata, che si estendeva fino alla Porta del Porticello o Saracena (detta anche De Vega, in onore del viceré), tra piazza S. Placido e via Dusmet; si giungeva poi al Bastione Piccolo, che si trovava alla marina, detto anche di Don Perrucchio, in onore di Perrucchio Gioeni, che aveva partecipato ad una spedizione in Tunisia con Carlo V. Proseguendo si raggiungeva il Bastione Grande o del Salvatore, tra via Dusmet e via Porta di Ferro, congiungendosi alla Porta di Ferro, in fondo alla via omonima, e al Bastione di S. Giuliano, così chiamato per via dell’omonimo monastero posto accanto, in piazza Cutelli.Continuando il percorso si arrivava alla Porta di S. Orsola, in piazza Scammacca, e al Bastione di S. Michele, il cui nome si riferiva ad una cappella vicina dedicata all’Arcangelo, nell’attuale Piazza Spirito Santo. La Porta di Aci (da cui partiva una strada che arrivava al Castello di Aci), o Stesicorea (per via della sua vicinanza alla tomba del poeta Stesicoro), si trovava nei pressi della chiesa dedicata a S. Carlo Borromeo; proseguendo si giungeva al Bastione del Santo Carcere, nella salita dei Cappuccini, vicino alla chiesa di S. Agata la Vetere, che andava ad unirsi alla Porta del Re, innalzata da Federico III d’Aragona. Andando avanti si giungeva al Bastione degli Infetti o del Vescovo, in cui era ubicata una torre di epoca medievale donata al vescovo Antonio de Vulpone, tra la via Plebiscito e la via Lago di Nicito; poco lontano si trovava il Bastione del Tindaro o del Tonnaro o, ancora, dell’Arcora, poiché nelle vicinanze vi erano le arcate dell’acquedotto di epoca romana che portava l’acqua da Valcorrente in città. Dopodiché il muro proseguiva verso il Bastione di S. Giovanni, tra via Garibaldi e via Plebiscito, congiungendosi al Bastione S. Euplio, tra piazza Cristoforo e piazza S. Antonio, e si univa alla Porta della Decima, così chiamata per via degli uffici delle tasse sulla decima che si trovavano lì vicino. Il muro scendeva poi ai lati del Castello Ursino, formando il Bastione di S. Giorgio e, voltando nell’attuale Via Scuto e via Zurria, arrivava al Bastione S. Croce, che difendeva la città dalla parte del mare. Il muro si congiungeva poi alla Porta dei Canali, completando il percorso. A causa della colata lavica del 1669 e del terremoto del 1693, le mura furono quasi interamente distrutte: parte delle mura furono utilizzate dalle famiglie aristocratiche più importanti della città per ricostruire i propri palazzi. La via del Plebiscito, inoltre, venne creata dopo il terremoto, seguendo il tracciato delle vecchie mura.
“Ti cuntu…” – Laura Gullotta
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
- MERODE, G.; PAVONE, V. Le origini: dal quaternario al terremoto del 1693, Catania, 1990
- SANTAGATI, M.; SCIFO, A. (a cura di) Catania medioevale. Itinerario guidato fra Storia, Arte e Leggende, Catania, 2003
- SANTAGATI, M.; SCIFO, A. (a cura di) Catania dei Viceré. Itinerario cittadino fra Storia e Arte dal 1410 al terremoto del 1693, Catania, 2003
Catania fortificata
di Etnanatura
Ritrovare le vecchie vestigia della città di Catania non sempre è facile e non sempre i pochi resti risultano di immediata leggibilità. Terremoti, eruzioni dell’Etna e, ancor di più, gli interventi sconsiderati dell’uomo che non hanno rispettato le testimonianze storiche, hanno reso arduo il compito di chi vuole riscontrare nel presente i ricordi del passato.
Il nostro percorso alla ricerca dei resti delle antiche fortificazioni della città di Catania inizia da un sito che si trovava fuori dalle mura della città.
Torre di Ognina. Pochissime notizie storiche ricordano questa piccola fortificazione durante i secoli passati. Sconosciute sono le origini: la tradizione vorrebbe che la torre fosse stata edificata sui resti del castello greco di “Italicon”, ricordato da Diodoro Siculo e, sembra, ancora in parte esistente fino al sec. XVI [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 292]. Sebbene Camilliani ricordi della cala di Ognina, della piccola chiesa a ridosso del porto e del relativo borgo, non fa alcuna menzione della torre [C. Camilliani ed. 1877, I, p. 325], che per certo doveva esistere secondo quanto risulta dalla descrizione di T. Spannocchi, contemporaneo del Camilliani: “…Avvi una torre fabbricata al presente la quale se bene è alquanto lontanetta però servirebbe per detta guardia et è di bona fabbrica…” [T. Spannocchi ed. 1993, XI]. Attualmente, infatti, la torre è molto arretrata rispetto all’attuale porto. Questa incongruenza trova spiegazione in un catastrofico fenomeno naturale: nel 1381 una colata lavica interra parzialmente la cala di Ognina [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 292], guadagnando terra al mare e restringendo l’accesso delle imbarcazioni al porto. Forse la torre venne edificata prima di questo evento naturale e, dunque, a ridosso del mare. Al di là di queste poche notizie storiche, non esiste alcun elemento che permetta di datare con esattezza la struttura, che, in via del tutto ipotetica, potrebbe collocarsi tra i secoli XIV e XV [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 294].
Garitte di Ognina e Piazza Europa. Del tutto simili a quella di S. Tecla in Acireale, le garritte di Ognina e di Piazza Europa sono situate la prima nei pressi del cosiddetto “Porto di Ulisse” e la seconda su di uno sperone di roccia lavica a ridosso di Piazza Europa. Entrambe presentano una architettura del tutto simile nelle dimensioni e nella muratura e sono espressione di una consolidata tecnica costruttiva militare spagnola durante il XVI secolo.
Duomo. L’impianto originario della basilica, edificata da Ruggero I d’Altavilla, risale al 1094, quando i normanni, strappata la Sicilia al dominio arabo, si impiantarono in città dando nuovo vigore al cristianesimo. Nel 1092, Papa Urbano II concesse al normanno Ruggero di ricostituire la diocesi di Catania affidando il potere episcopale all’Abate benedettino Ansgerio il quale sarà anche nominato signore feudale del vastissimo territorio della diocesi attribuendogli piena giurisdizione con il potere di amministrare la giustizia.
Ruggero per l’edificazione della Cattedrale scelse, in un primo tempo, il sito dell’odierna chiesa di Sant’Agata la Vetere dove nel 1091 aveva fondato il monastero Sant’Agata con l’annessa chiesa abbaziale. Nel 1094 preferì trasferire la sede vescovile nel cuore della città e l’antica Cattedrale venne denominata Sant’Agata la Vetere (ossia la Vecchia) per distinguerla dalla nuova che stava sorgendo.
Secondo Ruggero era necessario edificare la nuova chiesa sul mare, con muri spessi e nelle forme di una “Ecclesia munita” (chiesa – fortezza) non solo per difendere la città e il litorale dagli attacchi esterni, provenienti dal mare, ma soprattutto perché, con le sue forme, era chiara espressione dell’accentramento dei poteri politici e religiosi nelle mani del vescovo. (1)
Baluardo di sant’Agata. Del perimetro difensivo di Catania, infatti, proprio la cortina muraria a mare è stata quella che ha subìto maggiori rifacimenti, al punto che oggi risulta quasi del tutto impossibile stabilire quale andamento seguisse nelle epoche più antiche. Alcune planimetrie cinquecentesche permettono di ipotizzare che parte delle mura medioevali non fosse ancora stato abbattuto, permettendoci una vaga idea di come proseguissero le mura della città prima dell’erezione dei nuovi bastioni, ma nulla di davvero concreto. Così ciò che ci è noto è frutto di quel progetto di fortificazioni iniziato poco prima del 1550 su volere di Carlo V e fondamentalmente mai concluso. Nella sua Pianta topografica della città di Catania, Sebastiano Ittar ricorda che il tratto di mura alla marina – che a partire dalla Porta delli Canali circonda i palazzi dei Chierici e dell’Arcivescovato, passando dalla Porta Uzeda e chiudendo con la scomparsa Porta del Porticciolo – veniva impropriamente chiamato “Bastione di Sant’Agata”. Si tratta di una originale conformazione a W delle mura che, presso il transetto merlato della Cattedrale che fungeva da vedetta, stringe formando un vertice. (2)
Porta Uzeda. Per chi viene da via Etnea, la porta Uzeda costituisce l’uscita verso sud dalla piazza del Duomo. Essa collega il seminario dei chierici con il palazzo arcivescovile e la cattedrale di Sant’Agata. La porta si apre nelle cinquecentesche mura di Carlo V ed è intitolata al viceré spagnolo Giovanni Francesco Paceco, duca di Uzeda (in castigliano Juan Francisco Pacheco, Duque de Uceda). Il suo viceregno durò dal 1687 al 1696. La facciata del manufatto si rifà a quella del seminario dei chierici a cui è collegata e costituisce un fondale scenografico che unisce tutti i gioielli che si affacciano sulla piazza Duomo.
Porta Carlo V. Nota in passato come Porta delli Canali, prendeva il nome dall’omonima fontana sulla quale si affacciava, è l’unica porta superstite. La grande apertura, realizzata con largo uso di blocchi lavici ben squadrati provenienti probabilmente da un non ben identificato monumento antico, fa verso all’arte classica di cui sono evidenti citazioni le lesene a capitello tuscanico e il registro metopale che esse reggono. Su tutto una lapide marmorea incisa in caratteri e lingua latina che esprime il desiderio di Carlo V di dotare di mura la città di Catania, donde l’attuale nome. Un tempo aperta e ben visibile, a seguito della ricostruzione settecentesca venne inglobata da una fabbrica del sovrastante Seminario dei Chierici. La posizione e la presenza della lapide commemorativa, nonché l’interesse del Lanario di abbellire questo tratto di mura fanno pensare che la Porta fu destinata per essere la principale apertura a sud, in sostituzione della Porta del Porticciolo e della Porta della Decima. La monumentale Fontana dei 36 Canali da cui prese in passato il nome venne realizzata nel 1621, dietro un preciso piano di abbellimento e decoro voluto da don Francesco Lanario Duca di Carpignano, sulle mura di fronte alla Porta e sopra di essa stava una sorta di tribuna adornata con pitture che raffiguravano la storia del dio fluviale Amenano, ma venne distrutta poi dall’eruzione del 1669. Oggi una fontana ben più ridotta, la Fontana dei Sette Canali rimane a ricordo di quella maggiore in piazza Alonzo di Benedetto, non distante dalla Porta di Carlo V.
Piattaforma di santa Croce. Si tratta dei pochi resti di uni degli undici bastioni. Il bastione di santa Croce fu infatti completamento inghiottito dalla colata lavica del 1669.
Garitta castello Ursino. Datata tra il 1621 ed il 1637, venne costruita, su proposta dell’ingegnere militare Raffaello Lucadello, per il “riparo” dei soldati.
Castello Ursino. Il castello Ursino di Catania fu fondato da Federico II di Svevia nel XIII secolo. Il maniero ebbe una certa visibilità nel corso dei Vespri siciliani, come sede del parlamento e, in seguito, residenza dei sovrani aragonesi fra cui Federico III. Oggi è sede del Museo civico della città etnea, formato principalmente dalle raccolte Biscari e dei Benedettini. Il castello Ursino fu voluto da Federico II di Svevia e sorse fra il 1239 ed il 1250.[1] L’imperatore aveva pensato il maniero all’interno di un più complesso sistema difensivo costiero della Sicilia orientale (fra gli altri anche il castello Maniace di Siracusa e quello di Augusta sono riconducibili allo stesso progetto) e come simbolo dell’autorità e del potere imperiale svevo in una città spesso ostile e ribelle a Federico. Il progetto e la direzione dei lavori furono affidati all’architetto militare Riccardo da Lentini che lo realizzò su quello che allora era un imprendibile promontorio di roccia sul mare, collegata con un istmo alla città ed alle mura cittadine. Fu dotato anche di un imponente fossato e ponte levatoio. Probabilmente il nome di “Ursino” dato al castello deriverebbe da Castrum Sinus ovvero il “castello del golfo”. La costruzione, è a pianta quadrata, ogni lato misura cira 50 metri. I quattro angoli sono dotati di torrioni circolari con diametro poco superiore ai 10 metri e altezza massima di 30, mentre le due torri mediane sopravvissute (in origine erano quattro) hanno un diametro di circa 7 metri. Le mura sono realizzate in opus incertum di pietrame lavico e presentano uno spessore di 2.50 metri. Originariamente il castello presentava alle basi delle scarpate che lo slanciavano dandogli un aspetto decisamente imponente. Esse sono visibili nel fossato del lato sud del castello grazie agli ultimi scavi effettuati. Il lato settentrionale è quello principale ed è ben conservato con quattro finestre anche se originariamente non presentava aperture per renderlo meno vulnerabile agli attacchi nemici, qui l’entrata del castello era difesa da un ponte levatoio e da mura difensive i cui resti sono ancora visibili nel fossato di fronte all’entrata. Una base a scarpa rafforza la struttura del castello. Il lato sud è molto cambiato nel tempo, data la scomparsa della torre mediana e delle numerose finestre aperte nel tempo. Qui troviamo una porta secondaria detta “porta falsa” che, per mezzo di una scivola (che probabilmente era in legno e pietra), conduceva all’imbarcadero a mare ricavato oltre il bastione; il lato sud del castello infatti fino alla metà del XVI secolo era direttamente prospiciente la spiaggia e le acque del mar Jonio. Poi la realizzazione del bastione di San Giorgio e della piattaforma di Santa Croce lo allontanarono dal mare, ma lo resero efficiente per l’uso dei cannoni. Il definitivo allontanamento dal mare e l’innalzamento del livello del terreno circostante al castello fu dovuto alla colata lavica del 1669 che lo cinse quasi totalmente e sommerse i bastioni. Il lato est non presenta la semi torre ma vi si trova una meravigliosa finestra di età rinascimentale con un pentalfa in pietra nera lavica. I moderni lavori di restauro hanno portato alla luce fino ad ora parte dei bastioni cinquecenteschi, una garitta perfettamente conservata e gli originari basamenti a scarpa che oggi restituiscono l’originaria maestosità alle torri angolari del castello. Il progetto originale probabilmente non prevedeva una merlatura, rara nei castelli federiciani. Ma successive modifiche e ricostruzioni della parte sommitale di alcune torri, hanno probabilmente previsto l’inserimento di merlature. L’ingresso, semplice, si trova nel prospetto nord ed ha sopra in una nicchia una scultura raffigurante un’aquila sveva che afferra una lepre simbolo del potere del sovrano Federico II sulla città etnea, erroneamente scambiata talora per agnello[3]. Al suo interno si sviluppava la corte e vi rimane un bel cortile con scala esterna in stile gotico-catalano costruita in età rinascimentale, intorno all’atrio c’era una fuga di crociere quadrate che furono definite “campate di un maestoso tempio gotico”. Attorno al cortile interno c’erano le quattro grandi sale fiancheggiate da sale minori, dalle quali si accede alle torri angolari. Ogni grande sala è divisa da tre campate, coperte da volte a crociera costolonate che si dipartono da semicolonne con capitelli ornati a foglie. Dal piano inferiore al piano superiore si accedeva attraverso le scale a chiocciola posizionate all’interno delle semi torri nord e sud. Funzionalmente combinò sia la funzione di reggia (palatium) che quella di maniero (castrum). L’aspetto complessivo del castello nel suo ambiente circostante è notevolmente cambiato nel tempo, in origine si affacciava sul mare nei lati sud ed est, posizionato su un’altura a dominare il porto e la città bassa e reso imponente dalle scarpate. Dopo la colata lavica del 1669 e il terremoto del 1693, il castello vide allontanare la linea di costa di centinaia di metri e rialzarsi il livello del terreno di una decina di metri così che la sua imponenza e la sua magnificenza venne occultata per sempre.
Porta della decima. Secondo quanto riportato da Sebastiano Ittar nella sua Pianta topografica della città di Catania la Porta della Decima era nota anche come Porta Siracusa e nasceva in sostituzione dell’antica Porta Ariana. La sua esistenza è certa nel Medioevo, in quanto al di sotto di tale ingresso vi passarono i catanesi ribelli al re Federico in umiliazione sotto un arco di spade. Qui, dato il nome, avveniva il pagamento della decima, ossia un decimo del raccolto che veniva versato come tributo al sovrano. Ancora integra nel 1833, venne demolita per la lastricazione dell’antistante piazza San Giuseppe, oggi titolata piazza Carmelo Maravigna.
Porta del Fortino vecchio. Detta anche Porta di Ligne, era l’unica porta esistente nel Ridotto o Fortino, un tratto di mura eretto nel 1672 sulle lave ancora calde, distante dal sistema difensivo originario, ma facente parte di esso in quanto ne sostituiva la parte sud-ovest, irrimediabilmente perduta. Deve il nome al viceré Claude Lamoral I di Ligne che inaugurò il fortilizio entrando per tale porta in pompa magna. L’ultima testa coronata a passarvi fu Vittorio Amedeo II di Savoia durante il suo soggiorno siciliano, dopodiché decadde e si preferirono altri più comodi accessi, come la Porta Ferdinanda del 1768. Il Fortino datato un secolo divenne Fortino Vecchio e oggi la Porta, ancora ben visibile in fondo alla via Sacchero, prende tale nome.
Bastione san Giovanni. Rimasto illeso dall’eruzione del 1669 fu in parte distrutto dal terremoto che si verificò nello stesso anno. Ma furono l’incuria e il degrado dei secoli successivi ad alterarne definitivamente la fisionomia.
Bastione del Tindaro. Detto anche dell’Arcora (metà del XVI secolo). Facente parte della cortina muraria catanese, venne distrutto in parte dall’eruzione del 1669 e ricostruito nel 1674. Venne acquisito dai monaci benedettini che vi ricavarono il confine perimetrale del loro monumentale Giardino. ggi è visibile dal vico del tindaro e dall’interno dell’Ospedale Vittorio Emanuele.
Bastione degli infetti. Si trova sulla collina di Montevergine, antica acropoli di Catania. Già Cicerone, parlando dei furti di Verre, definisce il tempio di Cerere, Che doveva sorgere dove oggi troviamo i resti del Bastione degli infetti come tempio di gran culto. Ecco la citazione di Cicerone: “Nella parte più interna si trovava un’antichissima statua di Cerere, che le persone di sesso maschile non solo non conoscevano nel suo aspetto fisico, ma di cui ignoravano persino l’esistenza. Infatti a quel sacrario gli uomini non possono accedere: la consuetudine vuole che le celebrazioni dei riti sacri avvenga per mezzo di donne sia maritate che nubili…Esiste un’antica credenza che si fonda su antichissimi documenti e su testimonianze greche, che tutta l’isola siciliana sia consacrata a Cerere e Libera. Non è una profonda persuasione, a tal punto da sembrare insito e connaturato nel loro animo. Infatti credono che queste dee siano nate in quei luoghi e le messi in quella terra per prima siano nate in quella terra per prima siano state scoperte, e che Libera, che chiamano Proserpina, sia stata rapita da un bosco degli Ennesi”. In seguito il vescovo Leone II detto il Taumaturgo fece distruggere, come ricordano gli Atti Latini, il tempio utilizzando le sue pietre per costruire l’allora Cattedrale di Catania che corrisponde con l’attuale chiesa di sant’Agata la Vetere (vedi). Le Mura di Carlo V erano un complesso murario che venne fatto realizzare a Catania dall’imperatore Carlo V a difesa della città: esse erano costituite da undici bastioni ed avevano sette porte di accesso alla città. L’incarico della costruzione venne dato all’architetto Antonio Ferramolino all’inizio del XVI secolo ma la costruzione andò avanti con molta lentezza vista la complessità dell’opera. Esse racchiudevano completamente la città del tempo e la difendevano dai pericoli esterni. Ma, prima l’eruzione dell’Etna del 1669 e poi il terremoto del 1693 le rovinarono gravemente, ma la loro scomparsa definitiva si deve al piano di rinnovo urbano del XVIII secolo. Una delle poche testimonianze rimaste è costituita dal Bastione degli infetti costruito nel 1556 ad opera del viceré Vega.
Torre del Vescovo. Accanto ai resti del Bastione degli infetti ritroviamo la Torre del Vescovo. La torre si ritene fondata agli inizi del XIV sec. (1302 d.C.?) ed è parte integrante dell’antica cinta muraria aragonese. Venne acquistata dal vescovo Antonio de Vulpone e trasformata, insieme all’area antistante, in lazzaretto. L’edificio si caratterizza per la pianta quadrata e la tecnica edilizia (non uniforme) costituita da pietrame lavico appena sbozzato, inzeppato con frammenti di terracotta e legato insieme da malta. I cantonali sono rinforzati con blocchi di pietra lavica squadrati. Della torre si conservano solo tre dei quattro muri perimetrali, solo quelli rivolti verso l’esterno della cinta muraria. Si tratta, probabilmente, di un semplice accorgimento architettonico: in caso di assedio e di conquista della cinta muraria, gli attaccanti non avrebbero potuto utilizzare la torre contro la città, essendo essa, in corrispondenza del lato meridionale, esposta al tiro degli arcieri. L’edificio conserva solo le saettiere del primo piano, sebbene sia probabile che esistesse anche una seconda elevazione, oggi del tutto scomparsa. Il pavimento di entrambi i piani doveva essere ligneo. Non si conserva merlatura e la scarpa del pianterreno appare come aggiunta posticcia di tempi relativamente recenti. Nel XVI sec. il lazzaretto si estese, comprendendo oltre alla Torre del Vescovo anche il limitrofo bastione di Carlo V. Il nuovo complesso prese il nome di “Ospedale degli Infetti“» (3).
Bastione del santo carcere. Il Bastione del Carcere, erroneamente detto anche di Sant’Agata (la Cortina di Sant’Agata è infatti alla Marina), sorse nel XVI secolo a protezione della Vetere, la prima cattedrale della città, legata dalla tradizione ai luoghi del martirio di Sant’Agata. Di forma pentagonale e privo delle torrette cilindriche angolari, inglobava un sistema di mura e torri preesistente, forse di epoca tardo-antica. Dopo il sisma del 1693 fu in parte demolito per ricavarne la facciata della chiesa di Sant’Agata al Carcere, mentre nello spessore murario si crearono vari ambienti di comodo per la medesima chiesa. Tra Otto e Novecento la parete nord viene offuscato da una serie di edifici che vi si addossano sfruttandolo come parete portante, mentre il lato occidentale viene demolito per la creazione della piazzetta della Vetere. Oggi è una tappa obbligata per la Festa di Sant’Agata: erroneamente infatti si crede che la finestrella cinquecentesca della Guardia fosse quella da cui si affacciava sospirante la santa durante la sua prigionia. (4)
Bastione di san Michele. Iniziato nel 1555 e mai compiuto, il Bastione prendeva il nome dalla chiesa di San Michele, trasferita poi su via Etnea nel Settecento. Dopo il sisma del 1693 venne sfruttato per realizzarvi residenze e fu modificato al punto da renderlo irriconoscibile: del muro a scarpa rinascimentale rimane infatti appena una piccolissima porzione su via Coppola, dove rimane parte di un edificio settecentesco, dal cui civico 43 si può accedere al cortiletto ricavato nella piazza d’arme. Il resto dell’edificio è un elegante palazzotto nobiliare di primissimo Novecento, ormai privo di qualsiasi elemento che ne rammenti l’originale funzione militare. (5)
Bastione di san Giuliano. Le mura di vicolo della sfera sono ciò che resta del vecchio bastione di san Giuliano.
In collaborazione con “Ti cuntu”
Altre pagine Etnanatura:
- Mamma li turchi.
- Catania Romana.
- Il fantasma (il fiume Amenano).
- Il castello Ursino.
- Bastione degli infetti e torre del vescovo.
- Sant’Agata al carcere.
Se non espressamente dichiarato le notizie sono tratte da Wikipedia
(1) – http://www.cattedralecatania.it/fasicostr.aspx
(2) – http://urbanfilecatania.blogspot.it/2012/10/ripari-perduti-analisi-di-alcuni.html
(3) – http://www.medioevosicilia.eu/markIII/torre-del-vescovo/
(4) – http://etnaportal.it/catania/bastione_del_santo_carcere
(5) – http://etnaportal.it/catania/bastione_di_san_michele